
Photo by Hello I’m Nik 🎞 on Unsplash
di Claudia Bruno
In un libro letto tempo fa, Joanna Pocock, scrittrice canadese partita da Londra alla ricerca di nuovi stili di vita nel West americano, a un certo punto raccontava di essere stata allontanata e interrotta dalla giovane madre di una comunità, nel rivolgere un gesto d’affetto alla neonata che teneva in braccio per il fatto di arrivare dalla città, essere portatrice di microorganismi infettivi e potenzialmente pericolosi. È una scena a cui ho ripensato spesso, difficilmente avrei creduto di poterla vivere di persona.
Alla fine di febbraio ho preso un aereo per Roma. Sull’aereo c’erano sette passeggeri con la mascherina, erano tutti italiani. Mi ricordo di averli contati, ho pensato che fossero pazzi. Una di loro ha sostenuto per tutto il viaggio che i virus si diffondono attraverso gli zingari che rovistano nei cassonetti. Un altro spostava all’occorrenza la mascherina dalla bocca per bere una coca tra una scena e l’altra del film che stava guardando sullo schermo di un tablet. Tutto abbastanza in linea con quello che avrei visto giorni dopo: romani in maniche di camicia con i gomiti appoggiati al bancone aspettando una carbonara – mascherina sotto il mento e mano in tasca “me ce metti pure il pecorino”.
Per le strade di Roma le persone camminavano strette, si ammassavano in metro – qualche evento rimandato per prudenza,“vai a sapé”. Il resto, tutto come al solito – prosecchi e apericene, pizze al piatto e come sempre molti abbracci. Sui treni regionali qualcuno iniziava a ragionare sui contagi, “di come si potrebbe fare, poi, alla fine, a stare a un metro di distanza la mattina” – due regioni diviso cinque vagoni alla volta faceva sempre comunque meno di un metro. Si sapeva già che i bambini non avrebbero presentato sintomi, che le mascherine sarebbero servite fino a un certo punto. Comunque i controllori a Termini non c’erano più, ogni tanto qualcuno, nonostante il sole, si avvolgeva il naso in una sciarpa.
In quei giorni ha partorito una mia amica, non vedevo l’ora di conoscere sua figlia. Dalle foto sembrava uguale a lei, solo minuscola. Ero emozionata. Le inviavo fiori virtuali in attesa di incontrarla. La mia amica me lo ha detto per messaggio “mi dispiace, non la puoi vedere,questo virus mi spaventa, spero capirai”. Non ero sicura di aver capito, ma pochi giorni dopo avevo un aereo per Gatwick. Ad oggi non ho idea di quando tornerò, tutto quello che so è che quel momento è passato.
A Londra, sulla scrivania – un tavolo da pranzo dalla forma ovale ricoperto di ammaccature che ho sistemato in sala davanti alle finestre – c’è un dizionario etimologico, l’enciclopedia dei simboli, lo speciale di carta che il Guardian ha dedicato al giorno dell’addio all’Europa. Poi un’edera, un tronchetto, una pilea – a Roma ero abituata ad avere un fuori, qui è stata una delle prime cose a mancarmi, avevo bisogno di foglie.
Da qualche giorno sopra al tavolo c’è un computer in più, un paio di cuffie e un blocco di indisciplinati scarabocchi. Appartengono all’uomo che ho sposato a qualche mese dalla Brexit. Nato in Italia, come me. Venuto qui per lavorare, al contrario di me. Al mio ritorno, all’inizio di marzo, ha ricevuto una lettera dall’ufficio del personale: “smartworking preventivo” per il fatto di aver avuto contatti con me.
Adesso condividiamo il mio ufficio portabile. Un ripiano che cambia a seconda delle stanze e delle case. Libri diversi al variare delle stagioni, di sicuro un’agenda e un pc. La sensazione è che anche se ci ho messo quindici anni a capire come arginare l’impatto delle interruzioni domestiche su quello che faccio, devo ricominciare da capo. Mio marito mi parla, mi interrompe continuamente. Ho fatto un conto, in media per ogni tre frasi che scrivo alla quarta di sicuro mi dice qualcosa. “Come fai a restare seduta, dimenticarti di tutto” mi guarda come se mi vedesse per la prima volta. Non sempre rispondo ma so quando ho iniziato – avevo vent’anni, mentre scrivevo mia sorella mi tediava con delle interminabili lezioni di piano.
Lui si alza ogni dieci minuti. “Andiamo?”, mi chiede. “Camminare fa bene”. Da quando lavora a casa camminiamo anche due ore di fila, non importa se piove. Superiamo i resti del mercato, i grattacieli nuovi. Ci addentriamo nei sobborghi di villette a schiera. In silenzio raggiungiamo il bosco, ci inoltriamo tra i rami che si fanno più fitti. Da una piccola collina osserviamo la città come se fosse lontana e non ci riguardasse, poi torniamo indietro. Nel tragitto incontriamo tutte le case in cui siamo stati, quelle che abbiamo visitato o in cui saremmo potuti andare. È un viaggio a ritroso negli ultimi anni. “Ti ricordi la prima volta che abbiamo fatto questa strada?” gli chiedo mentre percorriamo la salita di Normanton Road. “Era prima del referendum, mia nonna era ancora viva, tuo padre ci vedeva bene” mi fermo per non continuare un elenco che rischia di diventare invadente.
Da quando l’Italia è stata chiusa, locked down dicono qui, mi è venuta la tosse. Ogni tanto mi capita quando sono nervosa. Ho passato le notti a leggere e rileggere sempre le stesse frasi – il significato di quelle istruzioni continuava a andarsene per conto suo, scivolava da un’altra parte. Chiusi in casa è un’espressione che può voler dire tante cose, adesso non me ne veniva bene in mente nessuna.
Gli italiani che conosco a Londra si sono “auto isolati”. Quelli che non hanno potuto vivono al centro di un attentato terroristico guidato dal governo “per salvare l’economia”. La mia vicina, italiana anche lei, ha ritirato sua figlia dalla scuola, ha chiesto al marito di lavorare da casa. Sono lì, dentro al loro appartamento al quindicesimo piano di un grattacielo, li guardo nelle storie di Instagram – di incontrarci di persona neanche se ne parla. È difficile abitare la distanza quando il tuo paese ha tutta l’impressione di diventare il futuro prossimo del pianeta. Sull’Italia sanno tutti le stesse cose, noi facciamo come se fosse qui adesso, e facciamo come se fosse ovunque. Per il resto Londra continua a girare come una giostra imprudente, in un modo molto simile a come girava Roma tre settimane fa.
“I contagi sono ancora bassi per fermare tutto” ci diciamo mentre camminiamo. Da giorni non parliamo che di curve e incidenze, percentuali e denominatori. Non prendiamo i mezzi, non mangiamo fuori – addio mostre, cineforum, Adho Mukha e lindy hop. Vicinanze di nessun tipo, vita sociale zero. Piccoli tragitti da casa verso casa. Mi chiedo quanto potremo resistere prima di impazzire, come farà Londra a chiudere nove milioni di persone nei suoi flat così stretti. Se servirà davvero questa quarantena che ci siamo imposti in anticipo rispetto quella “vera”, che a un certo punto arriverà, o se finiremo per ammalarcene prima. Per me, come per molti, ogni giorno in più rischia di fare una differenza importante. Le case sono degli inghiottitoi, adesso se ne accorgeranno tutti.
“Era il segno che dovevamo fermarci, prenderci cura di noi stessi, e gli uni degli altri, cambiare sistema” sento dire e leggo tante volte, in un andirivieni di cuoricini rossi e namasté. Lo sento dire da anni, ogni volta che qualcuno scopre su un referto medico una malattia, che gli muore un parente, che viene licenziato, che ha una gastrite. Ci sarà stato probabilmente un tempo in cui l’avrò detto anch’io. Ma quel tempo non esiste più.
Proverò a essere sincera. Quando il virus ha cominciato a diffondersi in Cina mia madre, biologa, mi chiamava tutti i giorni. Aveva smesso di chiedermi come stavo, che cosa stavo facendo, voleva solo sapere quante volte e per quanto tempo mi lavavo le mani. All’inizio ero scettica, anche un po’ infastidita da questa insistenza. Poi è successa una cosa strana: più il virus si diffondeva, attraversava i confini, più mi facevo serena. Nell’incertezza generale, mi preparavo a condividere col mondo quella che per me era una condizione d’esistenza: isolamento a domicilio, futuro incerto, eventualmente tosse secca e mal di testa.
La paura è arrivata dopo.
A Londra gli esperti dicono che l’outbreak arriverà tra quattro settimane. A distanza di poche ore l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia globale, il sindaco ha girato un video in cui sorride invitando le persone a non fermarsi, continuare tutte le attività, “a patto di lavarsi bene le mani”. Accanto a un piano di precauzioni collaterali e ancora modeste, il governo ha comunicato le stime di quella che si annuncia come la “peggiore crisi sanitaria” della storia più recente accompagnate da un premuroso “preparatevi a perdere i vostri cari prima del tempo”. Scrivo a un’amica arrivata qui come infermiera, mi risponde “abbiamo qualche caso, li stiamo isolando,ma sarà una merda”.
Con mio marito ci siamo divisi la casa. Io salotto, lui cucina. Il social distancing ci ha contagiati. Adesso al posto delle carezze ci scambiamo i meme – un tizio che fischietta cucinando due rotoli di carta igienica, una coppia che ha preso un cane da portare fuori, ma è finto. Per l’Italia non ci sono più aerei. Isolati su un’isola guardiamo l’Europa chiudersi dentro, ci diciamo che “la salute è un concetto grande”, sogniamo la Corea. Io, a volte, di cadere dalle scale che portano all’ingresso, per fortuna sto dormendo.
Al nono giorno di quarantena malediciamo Whatsapp e chi l’ha inventato, ci pervade una smania epidermica, stabilire un contatto mortale – l’evidenza è scientifica: non è tanto che “non dobbiamo fidarci di nessuno”, è accertato, a breve nessuno si fiderà di noi.
E non c’è niente da fare, le istruzioni per scampare il collasso si sovrappongono al programma di un governo inventato, che divide per comandare. Solo che stavolta è “per il nostro bene”. Siamo al centro di un cortocircuito politico, un disastro interiore. Restiamo iperconnessi, coi nervi scoperti attaccati alle macchine, non ci accorgiamo che rischiamo il burnout.
Adesso inviamo messaggi introdotti da “se sopravviviamo”. La sera sul divano ci aggrappiamo a un esercizio immaginario. Ci vediamo tra sei mesi dentro a un cerchio di auto aiuto per gli affetti da PCS (Post-Covid-Syndrome), o un acronimo simile che qualcuno di sicuro nel frattempo inventerà. Un po’ ridiamo, un po’ ci viene da piangere. Ma non lo facciamo. A casa stiamo insieme “troppo”, ci diciamo “non so se posso più stare con te”.
Dall’Italia riceviamo video di inni nazionali remixati e cori neomelodici alle finestre, videoappelli di influencer chiusi a chiave in appartamenti di lusso e ville con piscina. “State bene? Boris Johnson è un pazzo! Non riuscite a tornare?” mi scrivono le amiche che “stanno sclerando” perché in giro “ci sono le guardie e hanno chiuso tutto, pure i parchi”. Di casa non si può più uscire.
“Va tutto bene”, ci diciamo. Stiamo uniti e stiamo strong. Ma l’Europa non è la Cina.
In programmi intitolati “l’Italia ha capito, gli altri no” sentiamo affermare che il sistema sanitario inglese è privato, che il governo ammazzerà i vecchi per salvare i giovani con la selezione naturale. Ci ricordiamo a vicenda di mantenere uno sguardo attento, verificare le fonti, non credere a qualcosa a prescindere solo perché lo dice qualcuno che è d’accordo con te. Quella che stiamo vivendo non è una catastrofe ambientale, è la crisi di un“sistema sanitario internazionale”, del concetto di “salute”come lo abbiamo pensato finora.
Il sistema sanitario inglese è pubblico. Qui, come altrove,i respiratori non basteranno, ma chiamiamo il governo per nome.“Boris” sa dire tutto e il contrario di tutto. L’ultima volta: che la quarantena inizierà dall’isolamento degli anziani e dei più fragili, che cercheranno di limitare la chiusura delle scuole in modo che duri il meno possibile, che nel frattempo chi ha la febbre deve stare a casa. È il “solito” metodo diverso. Non tutti ci credono, nessuno ha la certezza che funzionerà. Ma anche qui, come nel resto d’Europa, diciamo spesso “speriamo bene”.
Nella Londra del giorno dopo la gente va ancora a ballare nei club e i programmi hanno gli applausi veri, ma è partita la catena del “si salvi chi può”. Istituti e università trasferiscono corsi e lezioni online, eventi si autoannullano a seconda dell’occasione, italiani prevedono che “moriremo tutti”. Amici nati e vissuti a Istanbul prima di trasferirsi in Inghilterra, sostengono di aver già contratto il virus e di esserne guariti nel giro di poco. Per loro l’Italia resta un caso particolare a cui rivolgono buoni pensieri “Hard times… I pray everyday” ci scrivono. Comunque mascherine per le strade niente, si va al pub, ma intanto i supermercati si svuotano. Negli scaffali non si trova più frutta,sapone, carta igienica. Le farine spariscono. Il Regno Unito è un paese d’importazione, tante volte abbiamo immaginato questo scenario pensando a un’hard Brexit. Adesso lo scenario è qui, anche se per altri motivi. Il grocery delivery procede tra esaurimenti e ritardi, ci scrive lettere per ricordarci di non comprare più di quello che ci serve. Molti, oltre alla fiducia, stanno perdendo la calma.
“Mi ascolti quando parlo?” mi dice mio marito “mi preoccupa la tua tranquillità”. Lo guardo sistemare sulle scale le bottiglie dell’acqua frizzante che ci hanno spedito al posto di quella naturale. Mi sembra un altro, è dimagrito, sul volto ha delle rughe in più, come se non lo vedessi da tanto tempo. Mi chiedo quanto ne serve a un cervello umano per comprendere un nuovo ordine delle cose. Se il mio è diverso, fatto peggio, se significa che mi sto estinguendo. Come diventerà “la nostra vita prima del vaccino”, che forme prenderà questo“stato di pandemia permanente”. Se le palestre avranno posti limitati, se impareremo a ballare senza toccarci.
In attesa di risposte faccio quello che negli anni ho imparato a fare meglio. Lentamente, mi stacco. Esco dal corpo, mi penso da fuori, tengo buona una parte di me, quella infestante che già aveva annodato i fili ai muri e agli angoli di carne. E poi taglio, con cura, dove il nodo non si disfa, con la fiducia che si riformerà con la stessa inspiegabile perseveranza con cui i giorni continuano a cominciare.
Ho paura di molte cose. Come tutti, anche che accada qualcosa alle persone che amo, di non poterle raggiungere da dove mi trovo. Sicuramente ho paura di non respirare, so come ci si sente. Ci sono diversi modi in cui si smette. Ne ho provati alcuni.
Però la sera, prima di dormire, c’è un pensiero che mi rassicura. Sul tavolo di una delle mie case passate, mia madre mi spiega come avviene la replicazione. Disegna un virus su un pezzo di carta. Ha la testa a forma di prisma, le zampe filiformi, sottili. “Cerca la cellula ospite per moltiplicarsi” mia madre fa un cerchietto con la penna a sfera. “Per un po’ sarà la casa del parassita”, spiega alla me ragazzina. Prima o dopo ci verrà a toccare tutti, mi dico mentre spengo la luce.Penso al pianeta infetto di Haraway, alle parole di Marie Curie, ai disegni di Ernst Haeckel. Se chiudo gli occhi vedo questa mappa,un planisfero in espansione che si è coperto di pallini rossi e all’improvviso è diventato piccolo.
Londra, 15 marzo 2020
Claudia Bruno, scrittrice e giornalista, è redattrice editoriale di inGenere e collabora con le pagine culturali de Il Manifesto.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

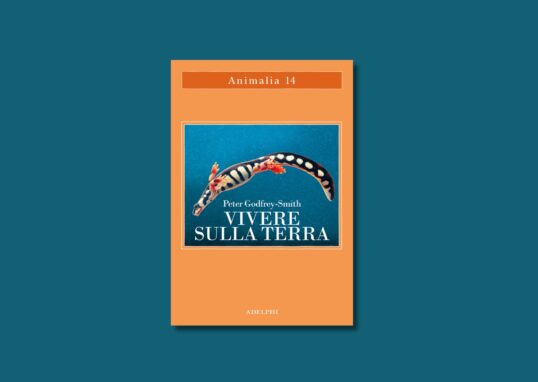





Belle riflessioni. Complimenti
Complimenti, belle parole dentro e fuori da un passaggio epocale. Grazie
Chi ama il crimine di alta qualità – non sei qui