
Questo pezzo è stato pubblicato in forma ridotta nella rubrica “Videoalterazioni” sul n. IX della rivista “D’Autore”, parte del progetto omonimo della Fondazione Apulia Film Commission, che rispondeva al quesito: “La televisione produce cinema seriale?”
Una serie tv che ha già costruito un intero nuovo standard, di complessità, di profondità e di bellezza: True Detective si muove su due differenti piani temporali – il 1995 e il 2012 – continuamente incrociandoli e intersecandoli. Di più: la narrazione procede come un unico flashback fino a un punto determinato, a partire dal quale prosegue nel presente e creando il futuro. In qualche modo, è come se i se stessi anni Novanta di Cohle e Hart consegnassero il testimone alle loro identità consunte, estenuate ma infinitamente più sagge di diciassette anni dopo. È il medesimo Rust a delineare la struttura metafisica della propria storia di personaggio, e della sua percezione da parte degli spettatori: “Nell’eternità, dove non c’è tempo, niente può crescere. Niente può divenire. Così la Morte ha creato il tempo per far crescere le cose che avrebbe ucciso, e tu rinasci nella stessa vita in cui sei sempre nato. Voglio dire, quante volte abbiamo già fatto questa conversazione? Beh, chi lo può sapere? Quando non puoi ricordare le tue vite, non le puoi cambiare, e questo è il terribile e segreto destino dell’esistenza.”
Questa maestosa articolazione di livelli e dimensioni riguarda non solo la parte narrativa di True Detective, la costruzione psicologica dei personaggi e dei dialoghi, ma anche quella visiva. Non solo il paesaggio meravigliosamente fotografato, quasi dipinto dagli autori, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto, e giustamente riconosciuto come il terzo protagonista (al punto che sono i suoi stessi elementi a formare l’identità di McConaughey e Harrelson nei programmatici titoli di testa): un paesaggio desolato e desolante, di relitti industriali e ciminiere alla deriva in pianure livide e paludose; un paesaggio instabile, in cui acqua e terra si confondono continuamente, fatto apposta per inghiottire i soggetti e le anime. Il lato visivo è costituito da un aspetto apparentemente trascurabile, in realtà al centro esatto della caccia al serial killer esoterico, il terrificante Yellow King.
Sono le “stick things” che segnano il percorso dei due detective nello spazio e nel tempo, indizi simboli e rappresentazioni dell’immaginario che anima ciò che vediamo fin dalla prima puntata. Le stick things, letteralmente “cose-fatte-di-stecchi, legnetti”, fanno parte di un’intera cultura visiva, molto americana, che diviene sempre più estesa e penetrante negli ultimi anni. Di certo un precedente può essere riconosciuto in The Blair Witch Project (1999): ma, se in quell’esempio esse svolgevano un ruolo tutto sommato decorativo, in questo contesto tutt’affatto differente esse hanno una funzione esplicativa. Condensano cioè l’attitudine, la disposizione d’animo dell’assassino – come dei suoi inseguitori. Questi oggetti al tempo stesso fragili e minacciosi, semplici e oscuri, vengono riconosciuti immediatamente da Rust Cohle come opere d’arte: manufatti in grado di veicolare non solo un’iconografia, ma una cosmologia.
***
Patte Loper, Your Rivers Your Margins Your Diminutive Villages Handwerker Gallery (Ithaca College 2014)
Queste opere stanno per una cultura visiva primitiva e molto contemporanea; pagana, intessuta di senso del sacro; terrestre e mistica. Quando Cohle contempla i piccoli oggetti recuperati sulla scena del crimine o la grande spirale allucinatoria costruita nell’incavo di un albero e disegnata dallo stormo di uccelli nel cielo, sta contemplando anche la visione collettiva di buona parte della produzione artistica occidentale del presente – che anticipa molto probabilmente i contenuti di quella del prossimo futuro. Una produzione che tende irresistibilmente all’arcaico, a un tempo prima e dopo la civiltà dell’ultimo secolo.
D’altra parte, ogni momento di profonda crisi evoca, e in un certo senso impone, la tensione al ritorno, la ricerca dell’autentico, del primigenio, del primordiale. È accaduto dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, con l’action painting e l’informale: nello snodo centrale del XX secolo (ciò che noi abitualmente pensiamo come un tutto unitario: e non lo è, affatto, a quella che possiamo considerare la fase arcaica delle avanguardie storiche, fatta di sperimentazione e ribellione (1907-1917), e alla fase classica del ritorno all’ordine percorso da tensioni metafisiche (anni Venti e Trenta), succede una vera e propria fase post-apocalittica (anni Quaranta e Cinquanta), con una produzione artistica che si percepiva per reazione come fondamentalmente astorica, sganciata dal passato e dalla tradizione: “Continuo ad allontanarmi sempre di più dai soliti strumenti del pittore come cavalletto, tavolozza, pennelli, ecc. Preferisco bastoncini, cazzuole, coltelli e lasciar sgocciolare la pittura fluida o un impasto pesante con sabbia, vetri rotti o altri materiali estranei aggiunti. (…) Quando sono ‘nel’ mio dipinto, non sono cosciente di ciò che sto facendo. È solo dopo una sorta di fase del ‘familiarizzare’ che vedo ciò a cui mi dedicavo. Non ho alcuna paura di fare cambiamenti, di distruggere l’immagine, ecc., perché il dipinto ha una vita propria” (Jackson Pollock).
È accaduto poi, nuovamente, durante i secondi anni Sessanta e i Settanta, con le varie aspirazioni ‘poveriste’, le meditazioni arcane del krautrock invenzione di una generazione cresciuta nel deserto della Germania sconfitta e divisa (Tangerine Dream, Amon Düül II, Popol Vuh, ecc.), il sogno arcaico-mitico proiettato da Pasolini per illuminare il passaggio d’epoca contemporaneo e la sparizione di un’identità culturale e collettiva (Edipo Re, 1967; Medea, 1969; Appunti per un’Orestiade africana, 1970; Le mura di Sana’a, 1971; Il fiore delle Mille e una notte, 1974).
Sta succedendo ancora, adesso, con la percezione oscura di una sorta di “futuro primitivo” che comincia a materializzarsi in opere visive, musicali, letterarie. La reazione creativa alla crisi consiste così nell’utilizzare in chiave post-apocalittica le macerie del mondo che conoscevamo: sulle rovine del mondo precedente, infatti, essa traccia le modalità per raccontare un nuovo inizio – e l’alterazione sottile ma radicale dell’intero sistema di valori che orienta le scelte degli individui. Questo, e probabilmente molto altro, è racchiuso nelle “stick things” e nelle fragili accumulazioni che invadono progressivamente serie tv, musei, libri e suoni.
Christian Caliandro (1979) è storico, critico d’arte contemporanea e curatore. Insegna presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia. Tra i suoi libri: La trasformazione delle immagini. L’inizio del postmoderno tra arte, cinema e teoria, 1977-‘83 (Mondadori Electa 2008), Italia Reloaded. Ripartire con la cultura (Il Mulino 2011, con Pier Luigi Sacco), Italia Revolution. Rinascere con la cultura (Bompiani 2013), Italia Evolution. Crescere con la cultura (Meltemi 2018), Tracce di identità dell’arte italiana. Opere dal patrimonio del Gruppo Unipol (Silvana Editoriale 2018), manuale Storie dell’arte contemporanea (Mondadori Education 2021) e L’arte rotta (Castelvecchi 2022). Dirige la collana “Fuoriuscita” per l’editore Castelvecchi. Dal 2004 al 2011 ha diretto le rubriche inteoria e essai su “Exibart”; dal 2011 cura la rubrica inpratica su “Artribune”. Collabora inoltre con “minimaetmoralia” e “che-Fare”, e dal 2017 dirige insieme a Angela D’Urso La Chimera–Scuola d’arte contemporanea per bambini presso TEX, ExFadda, San Vito dei Normanni (BR). Ha curato numerose mostre personali e collettive in spazi pubblici e privati, tra cui: The Idea of Realism/L’idea del Realismo, American Academy in Rome, Roma (2013); Concrete Ghost/Fantasma Concreto, American Academy in Rome, Roma (2014); Amalassunta Collaudi, Museo Licini, Ascoli Piceno (2014); Sironi-Burri: un dialogo italiano (1940-1958), CUBO-Centro Unipol Bologna (2015); Cristiano De Gaetano: Speed of Life, Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a Mare (2017); Now Here Is Nowhere. Six Artists from the American Academy in Rome, Istituto Italiano di Cultura, New York (2017); le quattro edizioni de La notte di quiete, ArtVerona, Verona, quartiere Veronetta (2016-2019); le sei edizioni del progetto Opera Viva Barriera di Milano, Flashback, Torino (2016-2021); il progetto Artista di Quartiere, Torino (2020); Z/000 GENERATION. Artisti pugliesi 2000>2020, AncheCinema, Bari (2020); Fragile, galleria Monitor, Roma (2021); Cantieri Montelupo, programma di residenze artistiche, Museo della Ceramica, Montelupo Fiorentino (2021).







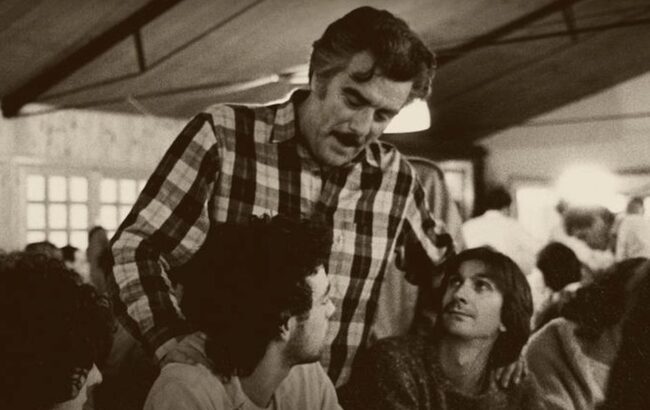
Fico.
Però m’era parso che i piano temporali narrativi fossero 3. Dicesi ellissi.
Per coloro i quali si son persi: il 1995, i giorni nostri, e il frattempo ricostruito dalle narrazioni dei personaggi e dall’indagine sull’indagine.
Se questo pezzo fosse scritto a mano, almeno si potrebbe giudicare come esercizio di calligrafia. Gli sticks è un po’ come fare le aste: un ingrediente di base per chi vuole seminare segni e simboletti (di carattere chiaramente derivative, contando che il folklore contemporaneo ha inventato Slenderman gratis e meglio) a eccitare lo spettatore che si crede intelligente. Grande è il campionario dei mezzi di frode narrativa. Certo stiamo parlando di pasticceria ricucinata in grande stile. Ma è più interessante demistificare che alimentare. O, se nelle cose precipitevoli conviene precipitare, suggerisco di ricollegare i legnetti al gioco di Perec.