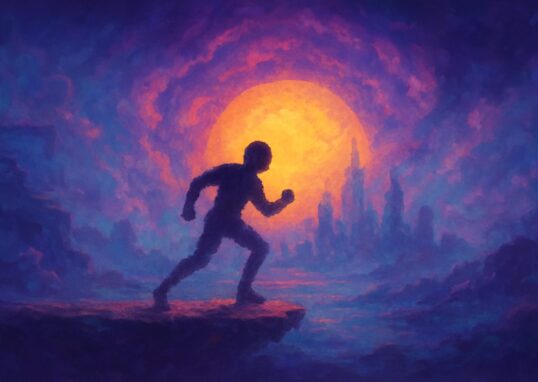Ci vorranno i dati ufficiali per poter dire davvero com’è andata questa stagione turistica in Puglia. A inizio agosto però la sensazione era quella di una crescita minore rispetto alle aspettative degli ultimi due anni: ecco quindi le lamentale di associazioni di categoria e le accuse un po’ in ordine sparso di speculazioni su affitti, ombrelloni e quant’altro.
Tutto sommato, e pronto ad essere smentito dai numeri, credo che alla fine avremo l’immagine di una crescita a macchia di leopardo: bene il barese, la Valle d’Itria e alcune zone del Salento, meno bene ad esempio lo Jonio tarantino, di cui ho avuto esperienza diretta.
Se nei primi due anni Covid (2020 e 2021) alcune spiagge della zona erano piuttosto affollate già a partire da inizio giugno, quest’anno abbiamo dovuto aspettare la prima decade agostana perché diventassero relativamente infrequentabili.
Cosa non ha funzionato? Da un lato il caro benzina ha evidentemente impattato sui “pendolari” (ovvero chi, muovendosi dalle città vicine, di solito affollava quotidianamente queste spiagge insieme ai turisti), da un altro il costo degli affitti, che invece ha toccato un po’ tutti: richieste di migliaia di euro per un mese a fronte di un’offerta assolutamente carente in termini di servizi. Senza dimenticare, nel complesso di quel che riguarda il turismo regionale, la ritrovata disponibilità di vicine (e relativamente più economiche) mete straniere, la Grecia su tutte, a seguito della minor pressione pandemica.
Ma al di là di generalizzazioni e numeri ancora da analizzare, il cosiddetto elefante è sempre lì, nella stanza della nostra bella masseria appena ristrutturata con piscina e ulivi mangiucchiati dalla Xylella: parliamo della qualità dei flussi quanto dei servizi, appunto, offerti dal comparto pugliese.
Proprio in spiaggia origliavo, poco dopo Ferragosto, i discorsi di una delle tante famiglie settentrionali arrivate in zona in camper. Ottimo mare, dicevano, ma servizi scarsissimi in fatto di ricezione, trasporti e viabilità. Poi la chiosa un po’ assurda di una signora del gruppo: «Troppo turismo fa male al turismo».
Detto da una turista potrà sembrare un paradosso, ma la signora aveva ragione da vendere. È cosa risaputa che in Puglia abbiamo messo in piedi un carrozzone ormai ingovernabile: per quanto negli anni si sia tentato di direzionare il settore verso flussi altospendenti e in linea del tutto teorica più consapevoli, da queste parti arriva sempre un po’ di tutto e l’impatto è devastante. E in fondo lo è a prescindere dalla tipologia di turismo intercettata.
La lezione, insomma, dovrebbe essere chiara a tutti: il turismo è un upgrade da effettuare su un sistema economico, culturale e sociale che funziona di suo, non l’elemento trainante in assenza di alternative, come appunto accaduto in Puglia.
È normale che in un contesto di perenne crisi economica, desertificazione industriale, inflazione e emigrazione giovanile a condizionare scelte e vocazioni dei “locali” siano le opportunità che si creano, per quanto estemporanee e predatorie.
Il turismo, che estemporaneo e predatorio lo è per definizione, per molti ha significato questo: dove, come soluzione individuale, non arrivava il posto pubblico o l’impiego in una delle poche aziende che ancora assumono in pianta stabile, ecco la messa a frutto di una rendita familiare o economica – almeno per chi ne aveva la possibilità.
La casa della nonna nel centro storico che diventa bnb, la masseria abbandonata che un tempo creava reddito per diverse famiglie reinventata come “dimora di lusso”, la villa al mare ristrutturata in fretta e furia per accogliere francesi, tedeschi e milanesi nel nulla cosmico di strade bucherellate e ristoranti improvvisati.
Nella speranza, non sempre realizzata, che tutto questo creasse reddito anche per altri e dunque un po’ di indotto per intere zone – cosa, anche questa, accaduta a macchia di leopardo e in maniera non sempre continuativa e coerente.
Nei fatti qui il predatore non è solo il turista ma anche chi accoglie, anche se nel nostro caso ci si è potuti difendere dalle accuse di auto-sfruttamento grazie a una sorta di imperativo morale di stampo identitario, come a dire: siamo tenuti a sfruttare questa terra perché l’amiamo, perché finalmente viene conosciuta e amata in tutto il mondo.
La riscoperta dell’identità come unica chance di sopravvivenza per una minoranza di pugliesi, insomma, ma anche come peccato originale. È vero che se non ci fosse stato questo sguardo da fuori ad aiutarci nello scoprirci e raccontarci a noi stessi, forse avremmo continuato a balbettare nel dire “Puglie” quando ci chiedevano da dove venivamo, ed è vero che il ritrovato orgoglio di essere pugliesi ci ha fatto dimenticare l’imbarazzo di essere meridionali. Ma a che prezzo?
Il turismo è un tipo loquace, di quelli che monopolizzano l’attenzione per una cena intera, per cui poi si parla di loro anche nelle tavolate in cui sono assenti. Oggi non possiamo fare a meno di parlarne ogni volta che si discute di tessuto economico (e ripeto) culturale e sociale pugliese. È un bene, ma fa anche male.
Al di là dei numeri di quest’estate, le contraddizioni sono sotto gli occhi di tutti. È arrivato il tempo di affrontarle: diversamente, il rischio per la Puglia è di diventare una di quelle mete esotiche che esistono solo nelle storie Instagram dei turisti o come location per grandi eventi e produzioni cinematografiche.
(Foto)
Marco Montanaro (1982) vive in Puglia, dove si occupa di scritture e comunicazione. La sua newsletter si chiama Sobrietà.