
È in libreria per i tipi di Editore Ultra il libro Miti Pop. Lavaggio a freddo, analisi, testimonianze, visioni e racconti sulle icone popolari del Novecento. Il progetto, ideato e coordinato da Mirco Delle Cese, vede i contributi di diversi autori (oltre allo stesso Delle Cese): Tommaso Ariemma, Lorenzo Barberis, Adriano Ercolani, Dario Marchetti, Diego Pierini, Emiliano Ventura e Luciano Morganti.
Presentiamo un estratto dal capitolo dedicato agli anni ’60 a cura di Adriano Ercolani.
Il Novecento è stato un secolo straordinario, in cui l’umanità ha raggiunto, nel bene e nel male, l’epitome della propria ontologica contraddittorietà: è stato il secolo dell’Olocausto e dei gulag, in cui per la prima volta si è pianificato lo sterminio di massa a livello industriale, eppure ha anche segnato conquiste storiche del progresso civile, come il riconoscimento di diritti fondamentali alle donne e alle minoranze; è stato scandito da conflitti mondiali di rara crudeltà, in cui l’onore cavalleresco delle guerre precedenti è stato spazzato dall’invenzione di nuovi tremendi strumenti di morte di massa e da una prassi sadica di violenze sui civili, eppure ha testimoniato un’accelerazione improvvisa del progresso tecnologico che non ha precedenti nella storia; è stato il secolo in cui il Potere ha perfezionato in maniera ossessiva le sue possibilità di controllo coercitivo, eppure negli stessi anni i medium di massa hanno consentito l’accesso alla conoscenza e all’informazione a miliardi di persone; è stato, non dimentichiamolo, il secolo in cui l’arte non ha solo sviluppato nuovi stili e generi, ma ha di fatto conosciuto per la prima volta nuove forme di creatività (dal fumetto, inteso come medium di massa, al cinema).
Di tutte le decadi che hanno composto il Novecento, quella degli anni ’60 è probabilmente quella che ha lasciato un impatto indelebile sull’immaginario collettivo, proprio per la convivenza delle dinamiche descritte, alla massima potenza: dal punto di vista politico, in dieci anni è accaduto di tutto, tra l’entusiasmo del Movimento dei Diritti Civili in America e l’insensatezza delirante della guerra in Vietnam, tra gli omicidi di icone, diversamente progressiste, quali i fratelli Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, la rivoluzione culturale di Mao Tse-Tung, la riforma della Chiesa Cattolica promossa da Giovanni XXIII nel Concilio Vaticano II, il ’68 francese.
Dal punto di vista della percezione collettiva, amplificata da media come radio e televisione, è impressionante la serie di eventi epocali accaduti in dieci anni, tutti collegati a un imminente senso di cambiamento, di rivoluzione necessaria per scacciare il rischio di una nuova guerra mondiale: la crisi missilistica di Cuba, con lo spettro apocalittico incombente di un conflitto nucleare; Juri Gagarin lanciato nello spazio, nella cornice inquietante della “guerra fredda”; l’avvento dei Beatles e di Bob Dylan; l’omicidio di John Fitzgerald Kennedy; le rivoluzioni guidate da Ernesto Che Guevara e la sua morte avvolta in nell’aura romantica della morte di un eroe generazionale; la Primavera di Praga, repressa dai carri armati sovietici, il sacrificio tragico e spettacolare di Jan Palach; la morte di Martin Luther King, che getta la comunità nera nello smarrimento, divisa tra cordoglio e desiderio di vendetta; le citate rivolte di Parigi nel ’68, che costrinsero Charles De Gaulle a portare l’esercito in strada; l’allunaggio che, con la sua coda di teorie negazioniste e complottiste, s’impone come uno dei più grandi momenti del progresso umano; il concerto di Woodstock che segna la manifestazione maestosa del sogno hippy, ma anche il suo canto del cigno, preludio al finale tragico del decennio.
Rileggete questa lista.
Rendetevi conto come gli eventi menzionati abbiano ancora un’enorme influenza oggi, sulla nostra quotidianità.
(…)
Non è un caso che, dopo decenni di idealizzazione melensa e nostalgica, probabilmente le opere che hanno raccontato meglio il decennio degli anni ’60 sono state realizzate più di quaranta anni dopo: mi riferisco alla magistrale serie tv Madmen (iniziata nel 2007), ideata da Matthew Weiner, e al film di Quentin Tarantino Once upon a time in Hollywood.
Solo col giusto distacco dagli eventi si può raccontare correttamente l’essenza di un periodo storico.
Madmen (forse la serie tv più bella mai realizzata) racconta il decennio, dall’America di fine anni ’50 intrisa ancora di ipocrisia maccartista all’inizio degli anni’70, attraverso lo sguardo cinico e privilegiato degli “uomini di Madison Avenue” (da cui il gioco di parole del titolo), ovvero le menti creative delle agenzie pubblicitarie di una delle arterie principali di Manhattan.
L’intuizione è geniale: raccontare l’epoca dei grandi sogni rivoluzionari, della speranza di cambiare il mondo, attraverso lo sguardo spietatamente manipolatorio di chi vende idee e desideri per soldi.
Indimenticabile è la figura di Don Draper, interpretato da John Hamm, geniale pubblicitario diviso tra il successo travolgente di una carriera in costante ascesa e l’inferno nascosto di una vita interiore divorata dai demoni del proprio passato, sfogati irrazionalmente in una voracità erotica e in una pericolosa tendenza all’autodistruzione.
Questa doppia anima (di brillante e cinico comunicatore e di personaggio quasi dostoevskijano nel lottare contro le proprie debolezze) dona a Draper delle antenne particolarmente sensibili per captare in anticipo i grandi sconvolgimenti culturali del decennio: tutto ciò che abbiamo, sbrigativamente, raccontato in questo capitolo (la guerra fredda, la crisi missilistica, la morte di Marylin Monroe, la guerra in Vietnam, l’ascesa dei Beatles e di Dylan, gli omicidi di Kennedy e Martin Luther King) viene sviscerato nella serie come riflesso nella vita, non solo, del protagonista, ma anche di tutti gli straordinari comprimari (Madmen è in realtà una grande narrazione corale), fino al finale (che non rivelo) sospeso tra illuminazione e totale disincanto.
Opera speculare, ma altrettanto illuminante, è Once upon a time in Hollywood, per cui non è enfasi scomodare la definizione spesso abusata di“capolavoro”, da molti incompreso.
In questo film, viene raccontato la fine degli anni ’60, attraverso la storia di un attore fallito e del suo amico e sodale stuntman (i due sono interpretati da Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, entrambi in forma eccezionale), avendo sullo sfondo la vicenda, tragica e straziante, del massacro di Cielo Drive, dove, tra le diverse vittime, perse la vita Sharon Tate, la bellissima attrice, moglie, incinta, del regista Roman Polanski.
Responsabili del massacro furono alcuni membri della setta guidata dal folle leader carismatico Charles Manson, che scrissero col sangue delle vittime titoli di canzoni dei Beatles tratte dal White Album (Helter Skelter e Piggies, attraverso le quali Manson sosteneva che il gruppo inglese gli avrebbe comunicato telepaticamente l’incombere di un’apocalisse nera piena di cieca violenza).
Un episodio orribile che sancì, nell’opinione pubblica, la fine sanguinosa del grande sogno hippie, complice anche la violenta manipolazione mediatica operata dal presidente Nixon.
Ora, chi scrive non ama Tarantino, soprattutto i suoi imitatori, che ne reiterano il citazionismo postmoderno da nerd sotto anfetamine senza averne né il genio, né il talento. Quindi, proprio perché questo film non è superficialmente “tarantiniano” (pur essendo in realtà una summa dei suoi lavori precedenti), probabilmente mi ha conquistato.
Il film, prima che al decennio in oggetto, è un monumento al cinema, non solo a quello di genere (che anzi, con somma autoironia, viene deriso, nel gioco di specchi e proiezioni del lato fallimentare di Hollywood): non alludo delle infinite, consuete citazioni (e autocitazioni) o della capacità straordinaria di ricreare un’epoca, appunto gli anni ‘60 (che si respirano in tutto, dai film al cibo al vestiario alla musica), ma del complesso gioco di scatole cinesi sul quale è costruita la trama: il massimo esempio ne è Margot Robbie che interpreta Sharon Tate che va al cinema a vedere la vera Sharon Tate sullo schermo.
Un rovesciamento del gioco pirandelliano dei Sei personaggi in cerca di autore.
La riscrittura della storia (già operata da Tarantino in Inglorious Basterds) non è soltanto un omaggio colmo di pudore alla figura tragicamente scomparsa di Sharon Tate, ma a tutti i sogni e gli ideali degli anni ’60.
Nel finale fiabesco a seguito della carneficina (“come sarebbe stato giusto che fosse andata la storia”), Tarantino mette al servizio se stesso, e il suo cinema, della vendetta impossibile.
Un film costruito su un gioco di specchi geniale, composto di mille sottili allusioni.
In un certo senso, Tarantino sottopone la storia degli anni ’60 a quella operazione di riscrittura trasfigurante della “realtà” che David Lynch compie nel primo tempo di Mulholland Drive.
Dunque, da un lato abbiamo la decostruzione, fedele quanto cinica, di Madmen, dall’altro la riscrittura poetica di Tarantino.
Due modi per poter riscoprire e comprendere il decennio di svolta del Novecento, in tutte le sue meravigliose potenzialità, in tutte le sue promesse non mantenute.
Come disse John Lennon: “Ciò che gli anni sessanta hanno fatto è stato mostrarci le possibilità e la responsabilità che tutti noi avevamo. Non erano la risposta. Ci hanno solo fatto intravedere le possibilità.”.
E la risposta, che racchiude tutto il significato di quell’epoca straordinaria, è in verso splendido e tremendo del suo amico, e ispiratore, ovviamente Dylan: “Non sono pentito di niente di quello che ho fatto. Sono felice di aver lottato, vorrei solo che avessimo vinto”.
Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di collaborare con Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo di arte e cultura, in varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai fumetti, dalla filosofia occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart, William Blake, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K. Chesterton. È vicepresidente dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde gratuitamente la meditazione, come messaggio di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a Scampia.
Nel suo blog spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca intellettuale. Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e ilfattoquotidiano.it.





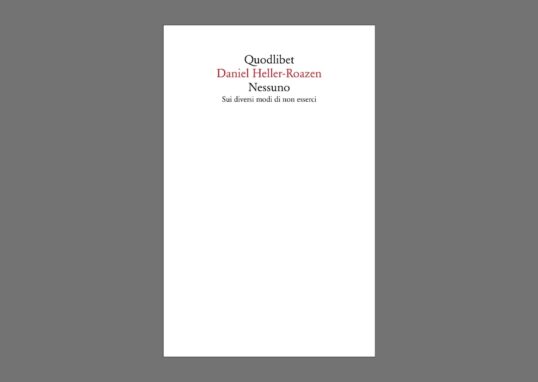

Decade è il periodo di 10 giorni. L’arco temporale lungo 10 anni è il decennio. Almeno voi, dai.
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/emdcadeem-solo-dieci-giorni-o-anche-dieci-anni/1761
Si può anche ammettere di aver usato un calco dall’inglese senza scomodare Carducci e Cecchi. Oppure si può ammettere di essersi sbagliati, lo facciamo tutti, persino a Patota nella sua risposta sul sito della Crusca sfugge “un ‘intervallo” con tanto di spazio prima di un apostrofo che non ci va.
Ho solo messo un link che mostra come si possa anche usare in quell’accezione.
Poi, posso anche ammettere d’aver sbagliato se vi fa piacere.
Ringrazio vivamente Adriano Ercolano per il piacevole articolo.
In risposta a Alessandro Montani: nell’articolo di Giuseppe Patota il segno grafico che lei chiama apostrofo è in realtà una virgoletta singola o apice, utilizzata per introdurre la citazione. Questo è quello che succede quando si legge per trovare gli altri in fallo piuttosto che per concentrarsi sul messaggio in sé.
In risposta a Sara: la fermezza che lei usa denota una rigidità di pensiero che non si addice alla mutevolezza intrinseca di una lingua. Il codice linguistico, come ci dimostra anche l’articolo di Patota, è in continua evoluzione: se ci si approccia pensando di avere la verità in mano è molto probabile che questa ci sfugga tra le dita.
Leggete per passione, non per combattere contro i mulini a vento.
Va bene, cara Silvia Alessandrini, allora concentriamoci sul messaggio:
“Il Novecento è stato un secolo straordinario, in cui l’umanità ha raggiunto, nel bene e nel male, l’epitome della propria ontologica contraddittorietà”.
Vorrei che Ercolani mi indicasse, dal Duecento a venire in su tanto per limitarci, un secolo non straordinario.
Ma in questo nostro secolo “straordinario” l’umanità avrebbe raggiunto “l’epitome della propria ontologica contraddittorietà”. Se lo dice lui. L’interessante è che l’epitome della contraddittorietà sia stata raggiunta “nel bene e nel male”. La precisazione è stata aggiunta affinché il lettore non si confonda: avrebbe potuto pensare che l’epitome della contraddittorietà fosse fra quelli che in vacanza vanno al mare e quelli che invece vanno in montagna, quelli che mangiano la minestra asciutta e quelli che invece la vogliono in brodo, cose così.
Quindi la contraddittorietà è fra il bene e il male. O no? Forse no, perché l’epitome della contraddittorietà è stata raggiunta “nel bene e nel male”, dunque sia nel bene che nel male. Il che vuol dire che c’è nell’uomo una ontologica contraddittorietà nel bene, e una ontologica contraddittorietà nel male. Mah.
In ogni caso nel Novecento abbiamo raggiunto l’epitome. Splendido. Cioè, voglio dire: splendida parola l’epitome. Quella che ci voleva in questo splendido e originalissimo periodo.
E via di seguito nello stile ercolaniano, tronfio, impreciso, scontato, popolar-accademico e pedante.
Ma naturalmente, come per la minestra, anche in fatto di messaggi tutti i gusti sono gusti.