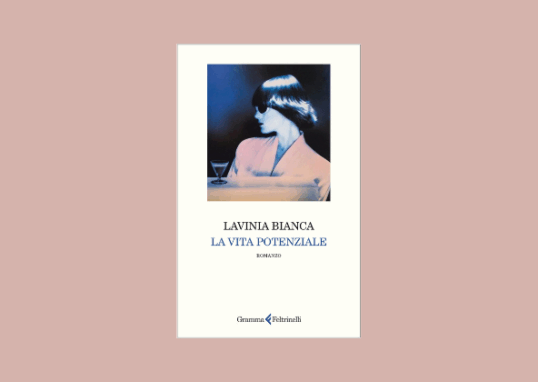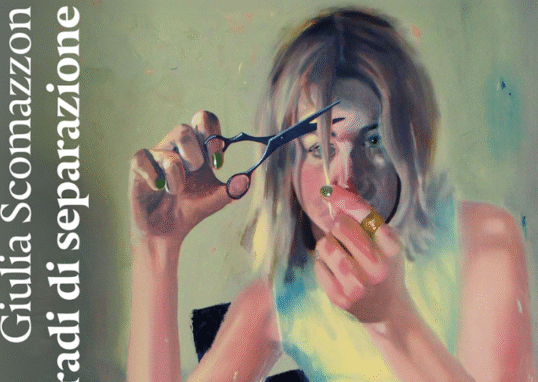di Manon Garcia (traduzione di Francesca Caiazzo e Noemi Magerand)
Sottomissione femminile e femminismo
Questo interrogativo, lungi dall’essere misogino, può perfino essere decisamente femminista. Il femminismo è un’impresa teorica e un programma politico di difesa delle donne che mira a promuovere una certa forma di parità tra i sessi – concepita nella differenza o come una forma di similitudine. L’agenda del femminismo prevede vari punti, e i primi due sono: mettere in luce l’oppressione delle donne in quanto tali e combattere questa oppressione.
Il primo punto porta il femminismo a proporre una critica sociale tesa a dimostrare il carattere sistematico delle disuguaglianze di genere, talmente diffuso e radicato nel tempo da aver permesso che tali disuguaglianze si costituissero nel sistema strutturale di oppressione patriarcale. Così, il movimento femminista si è storicamente adoperato per mettere in luce l’oppressione subita dalle donne in un contesto di dominazione maschile identificando, a livello individuale o collettivo, le ingiustizie vissute dalle donne ed evidenziando il carattere strutturale o generale dell’oppressione di cui esse sono oggetto. Questo primo punto, teorico, è una premessa per il secondo, ovvero la lotta contro l’oppressione, poiché permette di capirne il funzionamento. Per esempio, ci dimostra che la dominazione degli uomini sulle donne consente, e ha come effetto, di mettere a tacere le donne e sminuire sistematicamente le loro esperienze, come il cosiddetto lavoro di cura, ovvero l’occuparsi degli altri.
Questo primo punto permette anche di identificare i meccanismi di dominazione contro i quali occorrerà lottare e, in tal modo, contribuisce a costruire il secondo punto. Per esempio, poiché ridurre al silenzio le donne viene indicato come uno dei meccanismi della dominazione maschile, uno degli aspetti della lotta femminista contro l’oppressione patriarcale consiste nel fare in modo che le voci delle donne siano ascoltate e che la loro importanza venga riconosciuta, al contrario di quanto avviene nel sistema patriarcale in cui gli uomini parlano al posto delle donne. In questo senso, studiare la sottomissione delle donne è un’impresa femminista poiché consiste nell’ascoltare e nel prendere sul serio la loro esperienza, senza decidere a priori se siano vittime, colpevoli, passive oppure perverse.
Ciononostante, le femministe hanno accuratamente evitato la questione della sottomissione femminile[1], probabilmente per non dare l’impressione di fare il gioco dei conservatori, temendo che essi potessero considerare un simile argomento come una prova del fatto che le femministe stesse credono in una natura sottomessa e materna della donna. I machisti sono sempre pronti a dedurre che le donne sono sottomesse perché “in fondo a loro piace” e a negare gli effetti strutturali della dominazione maschile. Alcuni discorsi sulla violenza domestica sono un esempio calzante di questo fenomeno: lasciano sottintendere che ciò che le donne vivono non è forse così terribile se non parlano. Non parlare della sottomissione e accontentarsi di denunciare la dominazione degli uomini sulle donne permette dunque di prevenire la colpevolizzazione delle vittime. Questa precauzione pone un problema poiché ignora una parte importante del fenomeno globale e strutturale della dominazione maschile, ovvero la complicità che esso per l’appunto suscita. Si può, e si deve, studiare la sottomissione delle donne senza però presumere l’esistenza di un carattere tipicamente o naturalmente femminile.
Per capire la differenza fondamentale tra lo studio della sottomissione delle donne e l’ipotesi dell’eterno femminino, cioè di una natura femminile sottomessa, possiamo rivolgerci alla linguistica e alla filosofia del linguaggio. Occorre infatti distinguere due tipi di enunciati: quelli dei difensori di una natura eterna delle donne che dicono “le donne sono sottomesse”, e quelli che dicono “alcune donne sono sottomesse” o “alcune donne scelgono la sottomissione”. Nel primo caso, nell’usare un articolo determinativo a cui i linguisti attribuiscono valore generico (“le” donne, il quale implica tutte le donne o almeno le donne normali), si mettono tutte le donne nello stesso calderone, quello di una naturale sottomissione che le accomunerebbe appunto in quanto donne. Nel secondo caso, nessuna ipotesi viene enunciata riguardo alla natura o alla norma della femminilità, ma si dà peso ad alcune esperienze o alcune forme di vita singolari. Non affermiamo che tale sottomissione sia buona, cattiva, auspicabile o normale, ma soltanto che alcune donne, forse tante, forse poche, vivono in una situazione di sottomissione. Mentre il primo enunciato ha una dimensione normativa, gli altri due sono puramente descrittivi. Studiare la sottomissione delle donne è un’impresa femminista perché consiste nel descrivere un’esperienza vissuta dalle donne senza però considerarla come assoluta, naturale e necessaria per essere donna.
In definitiva, è un’impresa femminista perché adotta il punto di vista delle donne stesse come punto di partenza dell’analisi. Dopo il caso Weinstein, il mondo si è diviso più o meno in due parti: coloro che pensano che la società sia strutturata dalla dominazione esercitata dagli uomini sulle donne, e coloro che pensano che questa non esista oppure non sia, in fondo, così grave. Gli studi femministi dimostrano che tale divisione è problematica perché si fonda sul presupposto secondo il quale contano soltanto il punto di vista e le azioni degli uomini. In fondo, mentre si cerca di descrivere ed eventualmente contestare la posizione delle donne nella nostra società, se si parla di “dominazione maschile” si perpetua la consuetudine, a lungo evidenziata dalle epistemologhe femministe, di approcciare il mondo sempre dal punto di vista degli uomini, considerato neutro e obiettivo[2]. Sono gli uomini che dominano o non dominano, che stuprano, che seducono, che propongono, che godono, che tradiscono.
[1] Vi sono alcune eccezioni, la più notevole è sicuramente Saba Mahmood, Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject, Princeton University Press, Princeton 2011.
[2] Si veda per esempio Sandra Harding, “Rethinking Standpoint Epis-temology. What is ‘Strong Objectivity’?”, in Linda Alcoff, Elizabeth Potter (eds.), Feminist Epistemologies, Routledge, New York 1993.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente