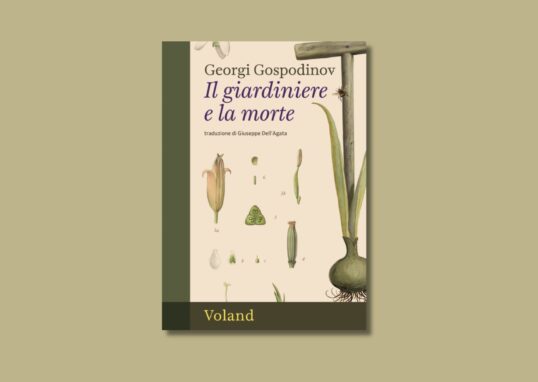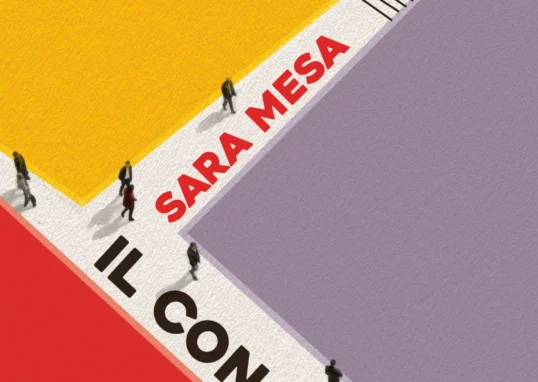«Ho in serbo un grande romanzo e mi piacerebbe andare in Francia a scriverlo quest’estate. Sarà breve come Gatsby ma allo stesso tempo avrà un approccio trascendentale, sarà il tentativo di mostrare la vita di un uomo attraverso alcuni segmenti osservati con passione». Questo scriveva Francis Scott Fitzgerald nel 1938 a Beatrice Dance, con cui aveva avuto una relazione anni prima, parlando di The Love of the Last Tycoon, romanzo pubblicato postumo un anno dopo la morte dello scrittore e ultimo grande frutto incompiuto di un’opera maestosa e che non perde nulla, con il trascorrere dei decenni, della sua potenza. Paolo Simonetti nella prefazione al romanzo, recentemente tradotto da Mara Baiocchi e Anna Tagliavini per minimum fax con il titolo L’amore dell’ultimo milionario, sottolinea da subito come le aspettative di Fitzgerald espresse nella lettera a Dance non possano che essere tradite: a differenza del Grande Gatsby, che effettivamente Fitzgerald scrive in Costa Azzurra nel 1924, L’amore dell’ultimo milionario non solo nasce e si muove in un territorio geografico diverso, Hollywood dove Fitzgerald si è trasferito nel 1937 per lavorare come sceneggiatore per la Metro-Goldwyn-Mayer, ma è anche scritto in uno stato d’animo del tutto diverso, funestato dalla malattia della moglie Zelda, dal fallimento incipiente della sua esperienza hollywoodiana nonché dal fallimento commerciale di Tenera è la notte (su questi anni finali dell’esistenza di Fitzgerald, minimum fax ha recentemente pubblicato anche il romanzo di Stewart O’Nan, Di là dal tramonto, dove l’autore mette bene in luce lo sforzo fitzgeraldiano di riordinare la sua vita dentro una patina di frustrazioni che non possono che farlo pensare, con rimpianto e nostalgia, al suo passato fulgente).
Per dare bene la misura di cosa si muovesse nella testa di Fitzgerald e delle direzioni che di conseguenza la sua opera letteraria stava imboccando, si può pensare al trittico che compone Il crollo, tre testi apparsi su “Esquire” nel 1936, in un momento in cui la schizofrenia di Zelda e il progressivo disinteresse dei lettori avevano fatto sprofondare lo scrittore nell’alcolismo fino a spingerlo a un tentativo di suicidio. «Anatomia di una coscienza delirante, autopsia effettuata sulla propria pelle, sermone funebre, canto del cigno», queste le definizioni di Ottavio Fatica dei tre scritti (emblematicamente intitolati Il crollo, Attenzione, fragile e Incollare), nelle pagine scritte per “Esquire” Fitzgerald fa i conti con se stesso e sfiora la consapevolezza della percezione di un fallimento esistenziale: si tratta di una confessione su una disgrazia (la «bancarotta emotiva») ma anche una nuova osservazione sulle sfaccettature della scrittura, qui dipinta nella sua impressionante inanità (anche se Fitzgerald è meraviglioso pure scrivendo della sua impossibilità di scrivere). L’anno dopo aver scritto questi testi come detto Fitzgerald si trasferisce in California, nel cuore della terra dell’ambizione e del successo, con l’impressione di essere, come scrive nel Crollo, «uno scrittore e basta», percezione di sé che forse gli sarà stata confermata anche dal fallimento hollywoodiano, dal mancato rinnovo del contratto con la MGM nel 1939 e dalla preoccupazione per poter pagare la casa di cura di Zelda e la scuola che frequenta la figlia. Eppure, come confessa anche in alcune lettere proprio alla figlia, Fitzgerald nonostante gli anni complessi che caratterizzano la stesura di L’amore dell’ultimo milionario (pubblicato postumo e poi ricostruito, nella versione che leggiamo qui, da Matthew J. Bruccoli, corredata da un importante apparato che riporta una selezione degli appunti di Fitzgerald e da alcune lettere che completano il discorso interrotto del romanzo) nutriva grande fiducia in questo lavoro dove condensava non solo alcuni elementi autobiografici, ma anche un’idea più generale dell’arte e della letteratura, della loro funzione e del loro peso all’interno di una società brutalmente risvegliata dalla crisi del 1929.
Protagonista del romanzo è Monroe Stahr, un uomo che ha costruito dal nulla la sua fortuna come produttore cinematografico e ispirato a Irving Thalberg, vicepresidente della MGM, ultimo tycoon dell’industria cinematografica: Fitzgerald aveva conosciuto Thalberg negli anni Venti, durante la sua prima esperienza hollywoodiana, e con lui non era mai andato troppo d’accordo anche se, come ricorda Simonetti, a Fitzgerald Thalberg «piaceva enormemente», come racconta lo stesso scrittore: «Thalberg mi ha sempre attratto. Il suo fascino eccezionale, la sua straordinaria bellezza, il suo immenso successo, la tragica fine della sua grande avventura». In una lunga lettera che scrive nel 1939 in cui racconta la trama del romanzo che ha in mente in quel momento, con una dovizia e precisione che testimoniano la fede nella serietà della letteratura che ha sempre nutrito lo scrittore americano, Fitzgerald mette già bene in luce il carattere di chi narrerà la storia, Cecelia, figlia di un produttore di Hollywood («una ragazza moderna né buona né cattiva, meravigliosamente umana. […] Lei è del cinema, ma non nel cinema. È nata probabilmente il giorno dell’anteprima di Nascita di una nazione, e quando ha compiuto cinque anni alla sua festa c’era anche Rodolfo Valentino») che si innamora di Stahr. Sempre attraverso il suo sguardo conosciamo l’altra protagonista di questo rapporto, Thalia, donna di cui invece è Stahr a essere innamorato e la cui relazione amorosa, traballante, dolorosa e confusa, è uno dei luoghi centrali del romanzo.
L’amore dell’ultimo milionario sembra essere un romanzo che Fitzgerald scrive mentre intorno a lui tutto crolla, crolla lui, crollano le sue speranze rispetto a un riscatto hollywoodiano e crolla l’intera società della post-depressione con i suoi personaggi più in vista, mentre il cinema hollywoodiano scimmiotta un benessere e una ripresa che sono molto lontani dal vero per buona parte della popolazione americana. Nello stesso tempo però Fitzgerald continua a scrivere, e lo fa fino alla morte che impedirà la conclusione di questo romanzo, fedele alla religione della scrittura, alla possibilità che narrare delle storie possa costruire un mondo diverso, con una speranza incrollabile nel mezzo letterario di cui questo romanzo è estrema e preziosa testimonianza. Deleuze ha scritto che alcune pagine di Fitzgerald sono esemplari rispetto al tema «di una “incrinatura” dell’Io, in rapporto essenziale con la forma del tempo intesa come istinto di morte» e L’amore dell’ultimo milionario, così come Il crollo, sembra incarnare perfettamente questa pulsione profonda dell’opera dello scrittore americano, che coglie la potenza della vita in tutte le sue declinazioni e cerca di restituirne l’essenza attraverso la parola scritta.
In questo romanzo, meritoriamente ripubblicato in questa nuova e ricca edizione, Fitzgerald riesce a condensare, in una storia che ha forti legami con la realtà, un’intera gamma di comportamenti e atteggiamenti che esulano dal singolo e dipingono l’umanità e la lotta, impari e continua, che l’uomo compie con la Storia e con i suoi simili attraverso la figura epica, vincente e perdente, fortunata e fallimentare allo stesso tempo di Stahr. Proseguendo nella sua analisi, Deleuze sottolinea come Fitzgerald abbia trovato nel ricorso all’alcol una delle modalità attraverso le quali poter sopportare questo spirito dionisiaco della vita e poter trasferire questa incrinatura sulla pagina senza soccombere. Continuando a leggere l’opera di Fitzgerald appare sempre più evidente come lo scrittore americano sia riuscito davvero ad avere una concezione profonda della vita senza rimanerne schiacciato e a raccontare, attraverso il dettato autoriale, questo nucleo profondo e pericoloso, a esprimere la potenza, eccitante, elettrizzante, tempestosa e atroce dell’esistenza.
Matteo Moca è dottore di ricerca in italianistica e insegnante. Scrive, tra gli altri, per Il Tascabile, Il Foglio, Domani, L’indice dei libri del mese, Blow Up e il blog di Kobo. Ha pubblicato le monografie “Tra parola e silenzio. Landolfi, Perec, Beckett”, “Figure del surrealismo italiano. Savinio, Delfini, Landolfi” e “Un’esigenza di realtà. Anna Maria Ortese e la dipendenza dal fantastico”