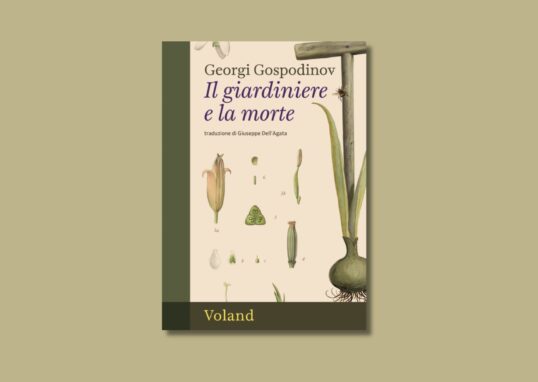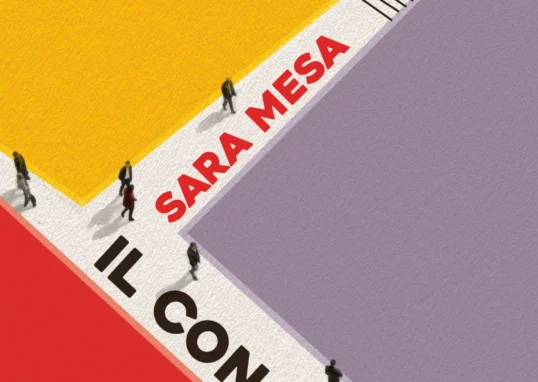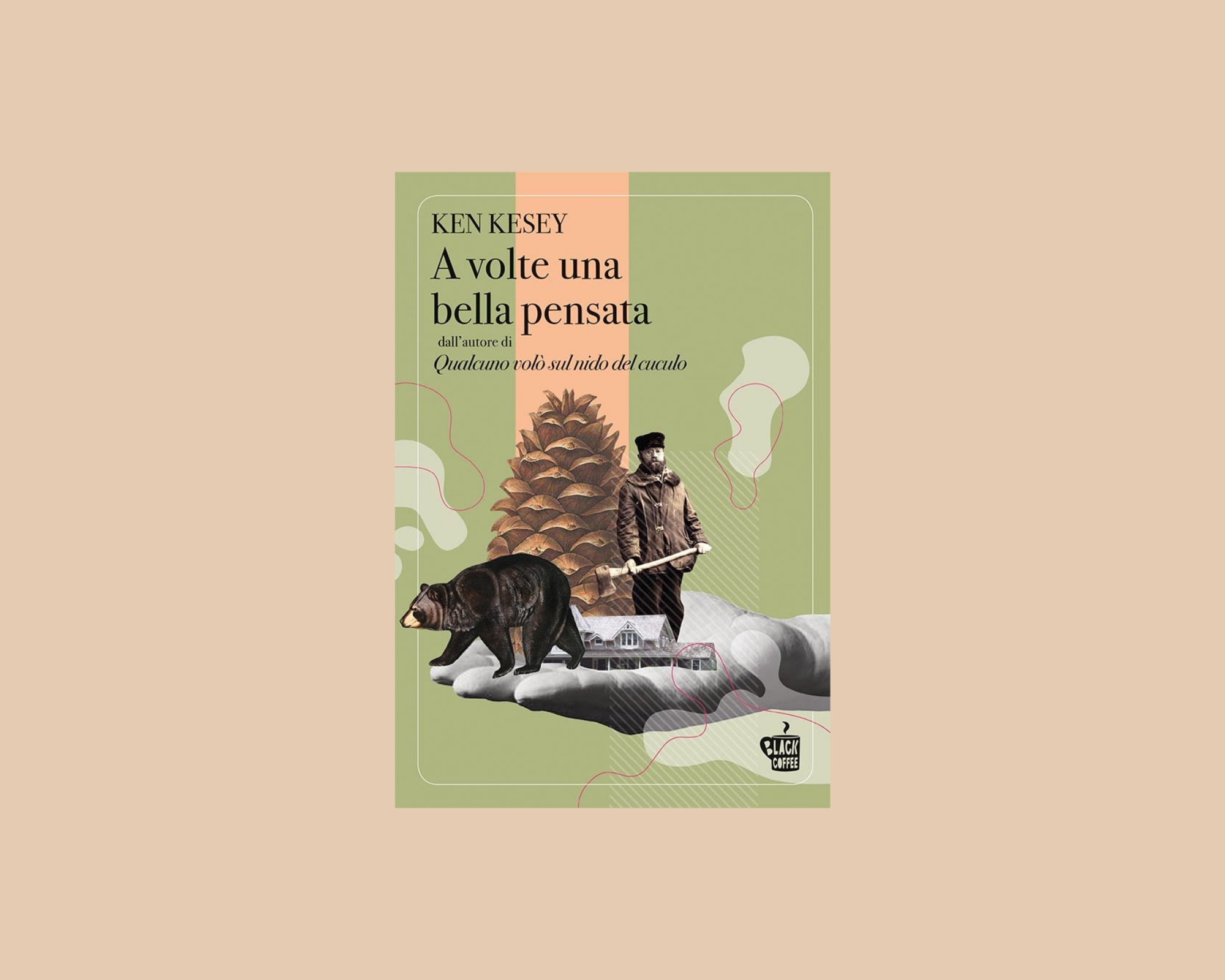
Fine anni Cinquanta. Stanford, California, Stati Uniti. Ken Kesey, originario dell’Oregon, deve ancora scrivere il romanzo che lo imporrà come uno degli scrittori più letti degli Stati Uniti: per ora frequenta i corsi di scrittura creativa all’università di Stanford, in California, e prende parte a uno studio sulle sostanze psicoattive, MKULTRA, che studia gli effetti di psichedelici come LSD, psilocibina e mescalina sulla mente umana, mentre lavora all’ospedale per veterani a Menlo Park. Nel 1962, anche rielaborando queste esperienze già così segnanti, scrive il romanzo che lo rende celebre, anche per il film che ne viene tratto, Qualcuno volò sul nido del cuculo: il successo è immediato e questo gli permette di lasciare Stanford e trasferirsi a La Honda, sempre in California, e dedicarsi, oltre che alla scrittura, a organizzare delle feste, “Acid tests”, che coinvolgono scrittori come Allen Ginsebrg e Tom Wolfe, ma anche musicisti del calibro dei Grateful Dead, spinto dal desiderio di saggiare i confini della percezione.
Ken Kesey raggiunge in questo momento lo statuto di guru, uno scrittore rispettato e ammirato, un trascinatore e un animatore controculturale: ma Kesey non sta con le mani in mano e continua a scrivere, lavorando al suo romanzo successivo, pronto nel 1964. Si tratta del voluminoso Sometimes a Great Notion, adesso tradotto per la prima volta in italiano da Sara Reggiani per Black Coffee con il titolo A volte una bella pensata, un testo prezioso e un tassello mancante dell’opera di Kesey finalmente disponibile per i lettori italiani, per chiunque sia interessato al mondo beat, che qui si trova nelle sue fasi conclusive, e alla narrativa americana che costeggia le atmosfere di William Faulkner, John Steinbeck e dello straordinario Larry McMurtry dell’epico western Lonesome Dove.
Questo libro è segnato anche dalle vicende straordinarie che ne accompagnarono l’uscita. L’editore organizza una festa di lancio con i maggiori editori a New York, sulla costa opposta a quella in cui si trova Kesey: spostarsi in maniera semplice non rientra nel novero delle possibilità e così Kesey e i suoi sodali, i Merry Pranksters, lanciati da tempo in entusiasmanti sperimentazioni lisergiche e artistiche, salgono su un autobus, il “Furthur” divenuto poi leggendario e guidato niente meno che dallo scrittore Neal Cassady, per giungere, come un fiume in piena, a New York. Le storie di questo viaggio, il “Magical Mystery Tour”, le possiamo leggere in Electric Kool-Aid Acid Test di Tom Wolfe, altro testo troppo poco tempo rimasto in libreria dopo la ristampa mondadoriana del 2013, dove il sagace giornalista americano ricostruisce le idee rivoluzionarie del gruppo, i vagiti controculturali, la fede nella psichedelia e molti dei momenti eccezionali che hanno costellato gli anni Sessanta americani.
Il libro di Kesey adesso pubblicato da Black Coffee è arricchito da una partecipata, divertente e attenta prefazione di Marco Rossari che non solo ricostruisce ciò che si muove, tantissimo, in questo romanzo, ma anche tutto ciò che ruotava attorno a Ken Kesey, la sua provenienza familiare e la società che si trasformava intorno a lui. Il titolo in lingua originale prende le mosse dalla canzone Goodnight, Irene, classico folk reso celebre da Lead Belly: «Sometimes I lives in the country / Sometimes I lives in the town / Sometimes I haves a great notion / To jump into the river an’ drown» recitano alcuni versi ripresi in esergo e nel romanzo di Kesey, che con il suo titolo sembra prendersi gioco anche linguisticamente dell’idea di nazione (“notion”-“nation”), troviamo la dialettica tra campagna e città, tra un mondo antico e uno moderno, e il pensiero, mai troppo nascosto, di un tuffo finale e irreversibile nel fiume, simbolo probabilmente di una natura a cui, alla fine, tutto ritorna e tutto cede.
Ambientato all’inizio degli anni Sessanta in un paese dell’Oregon, nel luogo del «febbrile scontro degli affluenti che sfociano nel Wakonda Auga», A volte una bella pensata potrebbe essere ridotto a un elaborato e intrigante romanzo familiare. Protagonista è la famiglia Stamper che approfitta di una rivolta sindacale degli operai del legno per continuare e lavorare e migliorare così la propria posizione, scatenando l’indignazione del paese, ed è la storia del padre Henry e dei suoi due figli, Hank, sempre lanciato nella conquista dell’approvazione paterna, e Lee, che invece lascia gli studi universitari per dare una mano all’azienda di famiglia tornando nell’Oregon, desideroso anche di chiudere una volta per tutte una storia rimasta in sospeso con il fratello Hank, con cui condivide il padre, ma non la madre.
Ma ciò che rende straordinario questo romanzo e che lo trasforma in una delle testimonianze più importanti sugli Stati Uniti degli anni Sessanta è la capacità di Kesey di immergere le vicende tra le pieghe della storia, senza però mai essere didascalico. L’opposizione tra un’America aperta al futuro e la resistenza di chi invece è attaccato al poco che ha, prende le sembianze dello scontro tra i due fratelli, tra Hank, provinciale, violento e accecato dal desiderio di venire finalmente considerato dal padre come un suo pari, e Lee, studioso e riflessivo, che quel mondo all’inizio non lo capisce ma con cui sente in qualche modo di dover fare i conti assecondando una strana attrazione. Uno scontro arricchito da un terzo e ambiguo oggetto del desiderio, Viv, la moglie di Hank, «la mia colonna di fuoco verso la salvezza, la mia torcia…», che con il procedere del romanzo diventa sempre più un elemento imprescindibile all’interno delle relazioni di forza che irrorano la storia.
Ma nella vita non c’è nero o bianco, la vita è fatta di sfumature e di accettazioni che sbiadiscono i toni sicuri delle idee e delle sicurezze, e così succede nel rapporto tra i fratelli, la cui relazione viene splendidamente raccontata in poche righe da Kesey, un piccolo saggio della sua scrittura che mescola in maniera naturale racconto e analisi psicologica in un continuo oscillare di punti di vista: «Risalirono la spiaggia. Hank davanti e un tremante Lee dietro: siamo legati, fratello, ammanettati insieme per tutta la vita, proprio come gli uccelli sono legati alle onde in una canzone di pazienza e panico. Duettiamo così da anni, io che pigolo e pilucco briciole e tu che fracassi e ruggisci, solo che adesso, fratello mio, i ruoli si stanno invertendo, e tu affranto inizi a intonare il canto del panico mentre io sento montare dentro il prolungato e mesto ruggito della pazienza in ritirata».
La relazione tra i due fratelli è solo uno dei temi di questo libro, che analizza i sentimenti umani più elementari e quindi più veri, come la vendetta, la prevaricazione o il desiderio di approvazione, di questa vicenda ambientata in splendidi paesaggi naturali dove la natura umana sembra essere un accidente casuale. Questa impressione di una «natura matrigna» e disinteressata viene confermata per esempio dal lavoro perpetuo dell’acqua, quella che cade dal cielo e quella che risale regolarmente dal fiume, un movimento naturale e disinteressato che costringe gli uomini a rattoppare continuamente le loro case, operazione che invece gli Stamper non fanno, preferendo una casa sbilenca e precaria, forse testimonianza proprio di quanto questa tra l’uomo e ciò che lo circonda sia in fondo una lotta impari che non può essere vinta e che non vale la pena combattere visto l’incombere continuo della rovina («Vi è un fatto singolare, tuttavia: non sorgono case direttamente sulla sponda del fiume – a esclusione della maledetta casa degli Stamper.»).
Come scrive Rossari riferendosi a un’annotazione del prefatore dell’edizione per Penguin del libro, c’è un’immagine di questo romanzo di cui è difficile liberarsi, ed è quella che racconta di un cervo che, dopo essere stato catturato e issato al bordo della barca, «bello che andato», stupisce gli uomini per la natura della sua paura: «non se la stava facendo sotto perché miseriaccia ladra stava per affogare o perché s’era ritrovato su una barca con noi. Per quel poco che potevo vedere, non aveva paura di qualcosa di preciso. Era paura punto e basta». Arrivati a riva il cervo improvvisamente sembra riprendersi e si lancia in acqua, ma non per nuotare verso la riva come gli uomini si aspettano, ma per puntare verso l’indefinito, irrazionale forse, se mai la razionalità possa esistere, ma libero: «Ha girato il culo, verso una bella onda che stava arrivando, e ha puntato al largo, più spaventato che mai». Un comportamento inspiegabile ma che, come suggerisce anche Rossari, svela anche il tema che accomuna tutte le forze vibranti che si muovono in questo libro, e che si collega idealmente al romanzo precedente di Kesey e alla sua vita, quello della libertà.
Ma Kesey non è uno scrittore accomodante o che pare mosso da un desiderio di consolare, quanto invece un uomo bramoso di lasciare solchi profondi nelle menti di chi legge. E così, in questa straordinaria epopea che mostra le sfide tra gli uomini guidate dal desiderio di dominio, quelle senza scampo contro la natura e la presenza perpetua della morte come elemento imprescindibile per la vita, forse l’unica via di fuga è proprio la libertà, la forza di scegliere di essere liberi, percorribile però solo a patto di provare a immaginare e capire cosa questa significhi.
Matteo Moca è dottore di ricerca in italianistica e insegnante. Scrive, tra gli altri, per Il Tascabile, Il Foglio, Domani, L’indice dei libri del mese, Blow Up e il blog di Kobo. Ha pubblicato le monografie “Tra parola e silenzio. Landolfi, Perec, Beckett”, “Figure del surrealismo italiano. Savinio, Delfini, Landolfi” e “Un’esigenza di realtà. Anna Maria Ortese e la dipendenza dal fantastico”