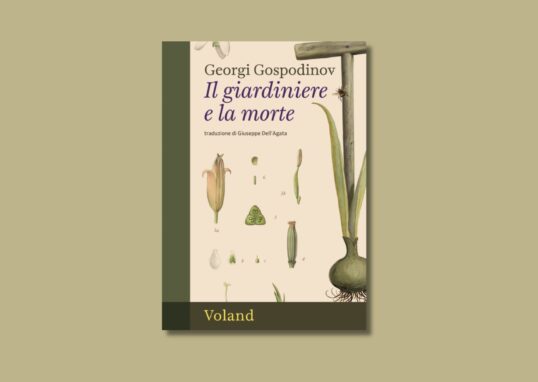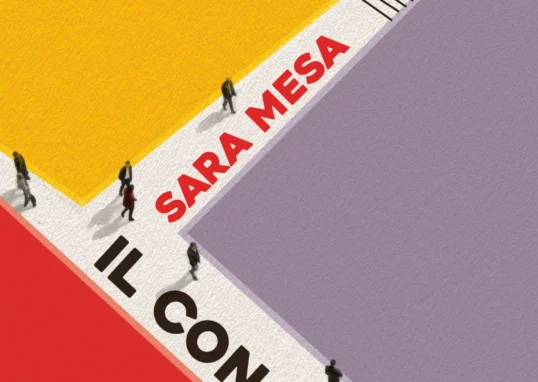Il processo di semplificazione che attraversa ogni ambito del mondo contemporaneo sembra, più o meno lentamente e con più o meno resistenza, inesorabile. La semplificazione non è per definizione qualcosa di negativo ovviamente, ma quando questa si accompagna al desiderio di dare maggiore velocità alle informazioni veicolate, addormentare il ragionamento e la critica, il processo diventa qualcosa di esecrabile, un movimento da condannare perché inutile. Il rischio più grosso è quello di una anestetizzazione del pensiero, l’abitudine alle cose semplici e la conseguente difficoltà dentro le complessità. Non è esente da questo rischio certamente la letteratura che se, come scrive Nabokov nelle sua lezioni di letteratura, afferisce al regno dell’inutile, è anche ciò che può dare «l’appagamento puro e assoluto», contribuendo alla serenità e al «benessere mentale più genuino». I libri che si pongono in controtendenza rispetto a questo processo, che non concedono semplificazioni al lettore, ma che invece lo trattano con il grado di difficoltà che una materia complessa come la scrittura e la letteratura deve scatenare, senza adombrare scorciatoie, sono dei gioielli rari e preziosi.
La sensazione che generano i saggi di Marilynne Robinson raccolti in Quel che ci è dato (appena tradotti da Eva Kampmann per minimum fax che ha in catalogo anche un’altra raccolta di saggi di Robinson, Quando ero piccola leggevo libri) è proprio questa e pare quasi di trovarsi davanti a un miracolo: ogni pagina, ogni riga di questi saggi invita infatti alla rilettura, all’approfondimento, ad andar a controllare le pagine precedenti, in un processo di lettura e interpretazione che pare senza fine. Questo accade non perché Robinson indugi in una complessità fine a se stessa, che potrebbe anche essere consona agli argomenti complessi che vengono trattati, ma perché ogni pagina e ogni parola risulta così densa di significati da spalancare continui spazi ermeneutici troppo intriganti per non essere percorsi.
Si prenda a esempio il testo che apre questa raccolta, intitolato Umanesimo: qui Robinson parte dalla definizione di Umanesimo, tratteggia in poche parole ma con grande precisione il clima e il significato delle azioni di quel gruppo di appassionati studiosi dell’antichità e poi getta in campo l’annosa domanda sull’utilità degli studi umanistici in un mondo come quello contemporaneo dominato dalla scienza e dalla tecnica, dove l’imaging cerebrale probabilmente non evidenzierebbe nulla di diverso nel cervello di Shakespeare rispetto a quello di qualsiasi altra persona: per un momento Robinson sembra quasi convincerci e convincersi del predominio della tecnica ma poi, improvvisamente, il ragionamento scivola in un vicolo cieco gnoseologico che non può che riportare alla questione descritta all’inizio del saggio, mostrando l’importanza del «valore dell’io umano». Nel giro di una manciata di pagine scorrono davanti agli occhi del lettore principi di critica letteraria, di neuroscienze, di storia della scienza (Darwin) e di teologia, magnificamente aderenti al ragionamento perché, ed è questo un altro pregio di Robinson, non c’è mai nessun eccesso di conoscenza, nessuna esposizione tronfia delle capacità di ragionamento; Robinson, come una saggia alchimista, dosa il suo sapere, ne utilizza quel che basta per rendere la scrittura e i ragionamenti brillanti e multiformi, come se osservasse il mondo attraverso una pietra preziosa e ci donasse la possibilità di gettare l’occhio anche a noi attraverso questo straordinario punto di vista.
Questo porta a una visione ben precisa della scrittura e della cultura, ben esemplificata nel saggio intitolato Riforma dove Robinson si muove tra i personaggi principali della grande riforma del cristianesimo nel Cinquecento, «soprattutto storia di libri e pubblicazioni», come Giovanni Calvino, Martin Lutero e John Wycliffe, tutti promotori di un cristianesimo più vicino e accessibile al popolo anche grazie al loro lavoro di traduzione della Bibbia, personaggi che si fecero carico di cogliere «la bellezza del parlato corrente» mostrandosi «sensibili alle qualità estetiche di qualunque cosa una cultura abbia stigmatizzato come un marchio d’ignoranza». Nelle storie della Riforma che si snodano attorno alla traduzione della Bibbia e al viaggio dei puritani verso gli Stati Uniti, viaggiatori antenati della Robinson come lei stessa suggerisce e che stridore tra la società da loro immaginata e quella americana di oggi, la scrittrice americana insiste sul fatto che le lingue vernacolari insieme alla «bellezza misconosciuta e la capacità di esprimere significati profondi che racchiudevano» rese «l’ampia diffusione del sapere possibile e urgente, oltre che un atto di godimento estetico e di grandissimo amore».
La diffusione del sapere avvertita come un bisogno urgente, come un atto d’amore, è forse una delle chiavi più profonde per comprendere l’opera di una delle più grandi scrittrici contemporanee che nei suoi romanzi, tradotti in Italia da Einaudi e forse non letti quanto meriterebbero, ha creato un mondo basato su una serie di interrogativi attorno a una meditazione religiosa onesta e profonda, suggerendo l’esistenza di un futuro che, come ha scritto Nicola Lagioia, «vale la pena di essere vissuto», illuminando «la dimensione dello spirito a cui potremmo accedere se avessimo la meglio su una serie di ostacoli interiori che rappresentano la nostra vera dannazione». L’afflato religioso è ovviamente presente in tutti i saggi di Quel che ci è dato, una sovrastruttura del pensiero che diventa decisiva per indagare i fenomeni della società (come il razzismo o l’economia contemporanea affrontati nei capitoli Risveglio, Declino e Paura, o la presenza della violenza nel vertiginoso capitolo Teologia), una questione di scontro e possibile pacificazione in un mondo come quello americano dove la religione diventa un modo, come scrive Robinson, per dividere la popolazione «in fasce». Robinson, che è calvinista, percorre il percorso della fede con coraggio e intelligenza (come emerge anche da questa intervista di Fabio Donalisio), non tirandosi mai indietro anche davanti ai luoghi più complessi, quelli dove il pensiero sembra girare a vuoto, ma la fede nel fatto che in ogni essere vivente è celata quella bellezza a cui «potremmo dare il suo momento di gloria» la spinge sempre ad andare avanti.
«Nella narrativa e nella vita c’è una grande differenza tra il conoscere qualcuno e l’essere informato su qualcuno. Quando un autore è informato su un personaggio scrive per la trama. Quando conosce il suo personaggio, scrive per esplorare, per percepire l’impatto della realtà su un sistema nervoso che non è assolutamente il suo»: questo scrive Robinson nel saggio Libertà di pensiero, contenuto in Quando ero piccola leggevo libri, e questa è una delle sensazioni che nascono nel lettore scorrendo le pagine narrative o saggistiche di Robinson, la forza di conoscere ciò di cui si parla e si scrive, l’audacia di vedere il mondo attraverso l’occhio dell’altro, il sentir risuonare una voce onesta e luminosa capace, davvero, di rischiarare i percorsi all’apparenza più tenebrosi.
Matteo Moca è dottore di ricerca in italianistica e insegnante. Scrive, tra gli altri, per Il Tascabile, Il Foglio, Domani, L’indice dei libri del mese, Blow Up e il blog di Kobo. Ha pubblicato le monografie “Tra parola e silenzio. Landolfi, Perec, Beckett”, “Figure del surrealismo italiano. Savinio, Delfini, Landolfi” e “Un’esigenza di realtà. Anna Maria Ortese e la dipendenza dal fantastico”