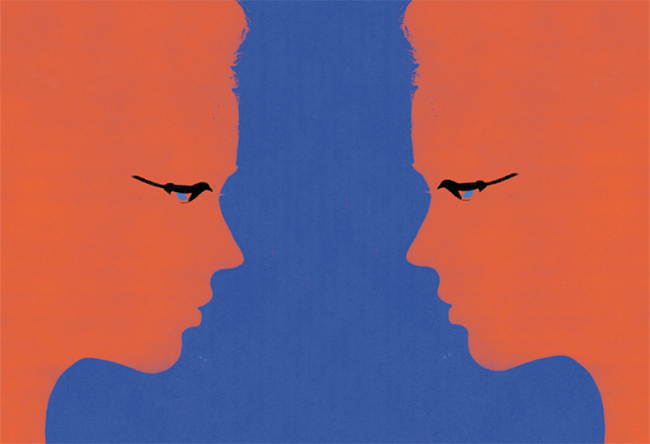
“Questa era seduzione. Questa era la storia che raccontò, fra tutte le storie da ragazzo di campagna che poteva raccontare.”
C’è un racconto nella nuova raccolta di Amy Hempel (Sem, 2019, traduzione di Silvia Pareschi) – gioiello in una lunga serie di piccoli gioielli – che è anche un manuale di scrittura in miniatura. Si intitola L’agnello orfano ed è lungo soltanto mezza pagina. Tutto il talento della scrittrice statunitense esplode in poche righe e regala al lettore un condensato di perle narrative, vertici impossibili da raggiungere e non imitabili. Nel testo si tengono insieme due livelli di storia, apparentemente distanti. Nel primo una voce racconta dell’azione di qualcuno che scuoia un agnello, gesti rapidi, secchi, violenti; nelle frasi successive la pelle dell’agnello viene legata al corpo dell’orfano, in modo che la pecora in lutto avverta l’odore e lasci che l’orfano si avvicini per poppare. Stacco. La voce fuori campo cambia registro, tono, tempo e luogo, solo con una frase: O almeno così disse.
Improvvisamente e, per il lettore, per sempre entra nel racconto chi narra, nella seconda parte c’è in ballo qualcosa di grosso, c’è seduzione, c’è forse una storia d’amore, c’è un uomo che fa un mestiere duro, legato alla terra, al lavoro con gli animali, che ha scelto di descrivere l’azione in cui il gesto brutale salva comunque una vita. Così, in pochissime righe, Hempel, fa vedere due personaggi, senza nominarli, un passato e un presente, fa vedere due corpi che si uniscono, uno sull’altro, protezione e amore, quello che verrà.
“Ho pensato vediamo cosa succede la prossima volta. Abbiamo ancora tante mele.”
Amy Hempel in ogni storia che scrive non dimentica mai il punto, il posto in cui vuole condurre il lettore, non fa giri inutili, non tergiversa, non descrive se non serve, non usa mai lo stesso registro, non si fa legare dalla necessità di dover raccontare in prima persona, non sente l’obbligo di usare la terza. Lei va al punto in centinaia di modi diversi, lo vediamo con chiarezza in questa nuova raccolta, ma anche andando all’indietro nelle raccolte precedenti (Ragioni per vivere, tutti i racconti, Sem, trad. Silvia Pareschi). Sceglie la storia molto breve, brevissima, il racconto a più voci, il narratore esterno, i dialoghi, il monologo, tante voci, una voce. Il luogo a volte è solo evocato, altre è nominato. L’ambientazione è sempre funzionale allo stato d’animo dei personaggi. Questi ultimi non hanno bisogno di essere descritti minuziosamente. Se hanno un taglio di capelli corto è perché serve al fine della storia.
È il racconto che mostra i suoi protagonisti, è la scrittura di Amy Hempel che porta ogni lettore con mano, lo tiene anche quando lo disorienta. Non usa effetti speciali, speciale è il modo in cui le parole si susseguono, decisiva è la sintassi, fondamentale è il passo. Hempel è compassionevole e molto ironica – in questo è più vicina a Grace Paley che a Raymond Carver (nonostante sia stata allieva di Lish) –, non insegue la scrittura minimale, persegue l’arrendevolezza del lettore dinanzi alla bellezza, ha un talento naturale per far sì che la lacrima e la risata non stiano troppo distanti. Bisogna saper perdonare e perdonarsi, bisogna comprendere gli altri. Leggendo questi 15 racconti più volte ho pensato: Saunders è un lettore di Hempel, del resto lo è anche di Paley.
Le storie di Hempel sono tenere e inquietanti allo stesso tempo, cos’altro abbiamo da chiedere?
“Le bambole formano il vortice e oscurano la stanza con tutto ciò che è stato trascinato dentro quell’imbuto […] e le bambole sono intere o senza arti, senza occhi, oppure hanno gli occhi splancati e i capelli ritti in testa.”
In un altro racconto molto breve Il Tornado di Bambole di nuovo, Hempel, lavora su due piani, e mette in relazione un’installazione dell’artista Kim Holleman e la tavola calda in cui quattro ragazzi neri si sedettero ad ordinare nel 1960. La connessione non la vediamo subito, la intravediamo nella seconda parte, e l’autrice dell’opera (e il tipo di opera) lo sappiamo solo dalle note poste alla fine. Ciò che conta è il ritmo indiavolato con cui si muovono le bambole nella prima parte e il modo in cui ci viene rivelato che siano conservate da qualche parte, in un luogo che è stato anche qualcos’altro e allora sappiamo che anche la tavola calda è un’opera d’arte che non è stata creata da un’artista ma è stata presa così com’è e portata in un museo per i diritti civili. Amy Hempel di questo vuole parlare e ci dice che si paga il biglietto per vedere entrambe le opere, ma intanto ha fatto in tempo a scrivere una prima parte di racconto degna di Silvina Ocampo e una seconda parte col piglio di Faulkner. Ci riesce solo perché è Amy Hempel, straordinaria.
“A volte quando una persona ti chiede se uscire a prendere la posta ti ucciderebbe, la risposta è sì.”
Donne che hanno subito un trauma, donne in fuga, donne che si supportano, si prendono in giro, poi uomini che si intravedono, partecipano, sono causa ed effetto. Un giro di vento, un ritorno a casa, una macchina che da New York raggiunge la Florida. Un’anima sola che ricorda. Una donna e un attore francese, una zia suicida.
“Io so di aver avuto tutte le soprese che posso sopportare.”
In un altro racconto una donna fa la volontaria in un canile, si occupa dei cani destinati alla soppressione. Stabilisce un rapporto empatico con gli animali, salvarli o almeno provarci non è altro che tentare di salvare sé stessa. Ti aggrappi al guinzaglio di un cane, lo culli prima che lo uccidano, dentro quel legame, quel respiro passato, ti salvi. In questa storia, dal titolo Un rifugio con tutti i servizi, Hempel adotta una tecnica ancora diversa, la protagonista mentre narra non dice chi è cosa fa, dice quello che dicono o hanno detto gli altri. Ogni paragrafo comincia con “Ci conoscevano come” e poi andando avanti “Mi conoscevano come”, un coro esterno si occupa di costruire il personaggio e di montare la storia. La protagonista ce la riporta, ci dice chi è per quello che gli altri hanno visto o detto.
“A un certo punto, sembrerebbe, occorre smettere di affezionarsi, e smettere di cercare di proteggere ciò che altri sono decisi a distruggere.”
Per il racconto più lungo del libro possiamo usare, senza paura, la parola capolavoro, il titolo è Cloudland, la protagonista è una donna che di anno in anno, di luogo in luogo, di memoria in memoria, di incontro in incontro, ritorna sulla scelta compiuta da ragazza quando ha partorito in un posto dove qualcun altro sarebbe venuto ad adottare la sua bambina. Non può che ritornarci sopra, il tempo non cancella, gli eventi si ripresentano in vari modi, anche a distanza di anni e di molti chilometri. La donna fa un piccolo percorso all’indietro e intanto è alle prese con le faccende di tutti i giorni, in un posto nuovo che sta imparando a conoscere. Il dolore non la abbandona e non abbandona nessuno dei personaggi di Hempel. Torna indietro perché non può far altro che tornare, ma torna a metà, non si concretizza il ritorno perché c’è troppo in mezzo. Cosa è stata la clinica, dove è adesso la figlia, di cosa parla un libro, c’è speranza, c’è salvezza, la testa potrà riposare da qualche parte? E il cuore?
“Anche se immagino che molti di noi siano stati ingannati. Io sicuramente mi sono ingannata di tanto in tanto.”
Amy Hempel ha scritto un’altra raccolta indimenticabile, con uno stile inconfondibile – reso molto bene da Silvia Pareschi – , che non cede alla retorica, ma ci mostra per ciò che siamo. Tutti quanti portiamo addosso i segni di una ferita o di un trauma. Tutti quanti ci siamo salvati qualche volta di poco, altre volte non ci siamo riusciti. La scrittrice ci cura perché si prende la briga di metterci davanti agli occhi i limiti del nostro essere umani e, allo stesso tempo, ci mostra come ogni tanto riusciamo ad andare oltre e a sollevarci. Ci salviamo con un abbraccio, non rispondendo a una telefonata, facendone una, salendo in macchina, guardando una mela cadere, piangendo o amando. Nessuno è come qualcun altro, infine, è un libro fatto di epifanie e rivelazioni, pieno di pagine di puro stupore.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/







1 commento