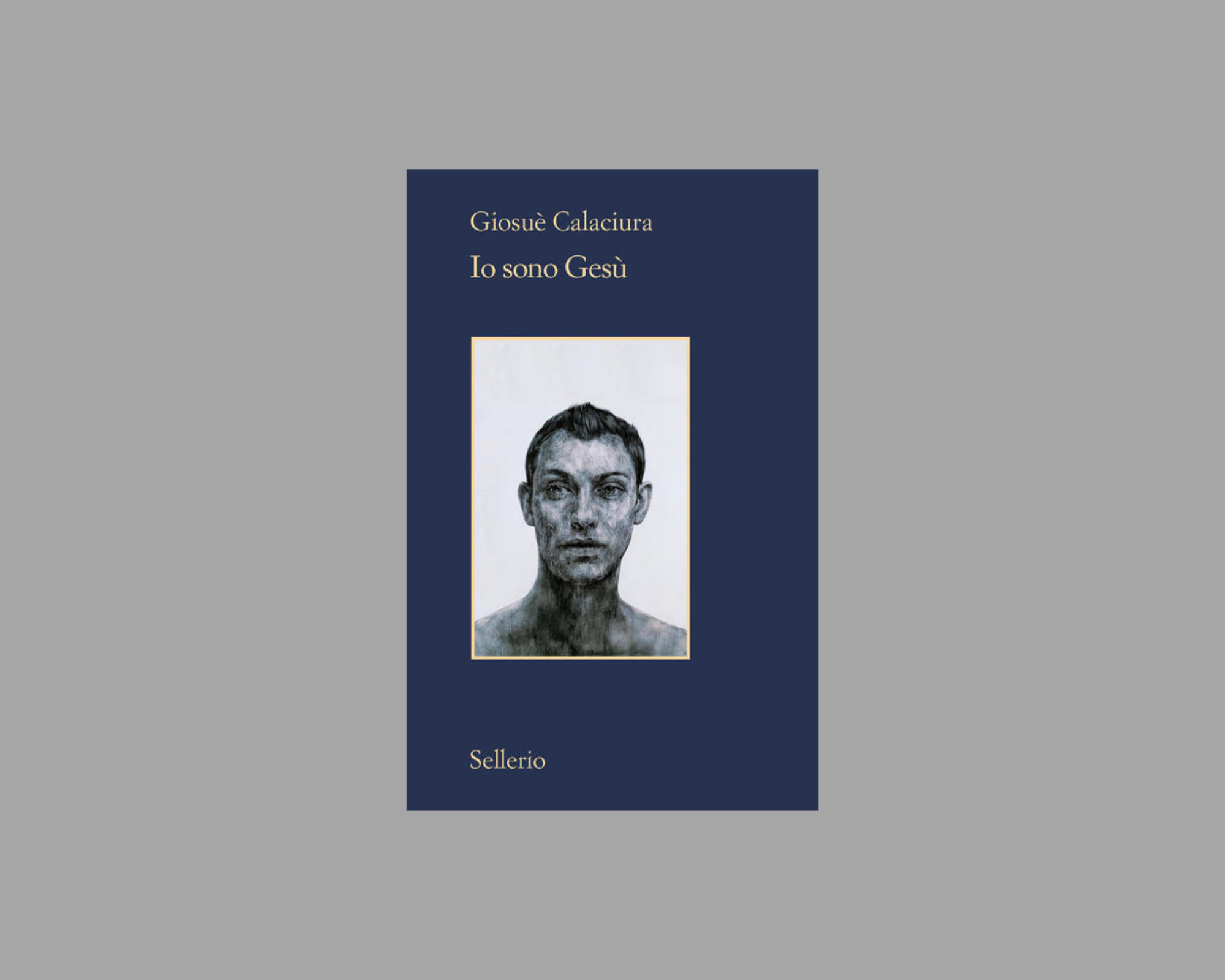
Nella battaglia sempre un po’ improvvisata della narrativa, gli scrittori sono quelli con l’arsenale di partenza più deludente: solo quattro verbi, “volere”, “immaginare”, “architettare” e “incaricare”. I loro piani si svolgono per mano di altri agenti, più versatili perché irreali, ubiqui, e capaci di muoversi tra dimensioni: a ogni loro azione dentro le pagine corrisponde un’altra uguale e contraria fuori, nella mente del lettore.
Un esempio, rapido e famoso. Verso la fine del suo Vita di Pi, lo scrittore Yann Martel introduce due personaggi, i funzionari giapponesi, che, con la scusa di interrogare il protagonista, di fatto costringono chi legge a ragionare sulla sospensione d’incredulità. Noi non abboccheremo, sottintendono, a un ragazzino che dice di aver trascorso sette mesi su una zattera in mezzo al Pacifico in compagnia di una zebra, un orango, una iena e, soprattutto, per la maggior parte del tempo, una tigre del Bengala; e voi, là fuori? Ma ecco che, rapida, arriva la provocazione: Pi racconta sul gong l’altra versione, più stringata, dolorosa e realistica. Dopodiché, domanda: «Visto che per voi non fa nessuna differenza e che non avete alcun modo di scoprire quale sia la storia giusta, quale preferite? Qual è la storia più bella, quella con gli animali o quella senza animali?». E i funzionari, subito, senza consultarsi: «La storia con gli animali».
La fantasia, opportunamente modellata, rende la vita (propria, altrui) più sopportabile e interessante — motivo per cui gli scrittori, pur scarsamente equipaggiati, si intestardiscono a battagliare. Ma cosa succede se un romanziere prende la vita celebre e mitizzata per eccellenza e la spoglia di ogni presunta esagerazione? Può un romanzo de-romanzare? Io sono Gesù (Sellerio), il nuovo libro di Giosuè Calaciura, risponde a questi interrogativi capovolgendo la prospettiva di Yann Martel: per Calaciura, infatti, se la versione egemone di una data storia è quella che contiene elementi di straordinarietà, la fantasia starà nel riscriverla per sottrazione. Anche perché, soprattutto: cosa significa “storia più bella”? Più bella per chi?
Gesù, qui, è un adolescente come tanti. Vive a Nazaret con la madre, che lo ha avuto giovanissima, e con il padre, un falegname taciturno. Il punto di rottura nella sua vita serena e piuttosto monotona di figlio unico amatissimo si deve proprio a questo genitore maturo e imperscrutabile che un giorno abbandona la famiglia senza lasciare messaggi, né tracce. Per Gesù, ragazzino inquieto, è un colpo durissimo. Così, dopo un’iniziale resistenza decide di lasciare il villaggio. «Madre. Quanto è stato duro, e quanto dolore mi è costato voltarti le spalle, partire. Ma dovevo trovare mio padre».
La prima cosa che salta all’occhio del Gesù di Calaciura è una certa tensione tra la via tracciata da Giuseppe (l’inesplorato) e quella, preminente, tracciata dalla madre (la casa, il legame, i ritorni inesorabili). Il risultato, come ha fatto notare Marcello Benfante su Repubblica, è il profilarsi di un Gesù «matriarcale, per il quale la madre rappresenta il principio e il senso stesso della narrazione». Vero. Se in Io sono Gesù c’è una volontà da farsi, è quella materna; se si intravede una qualche forma di fede o religione, è perché Calaciura l’ha nascosta negli sguardi, frequentissimi, che il figlio rivolge alla mamma. A lei si deve ogni slancio di coraggio del ragazzo, ogni illogica speranza, ogni sospetto che un destino grandioso, nonostante la vita di stenti, attenda entrambi oltre la stalla, la falegnameria, il piccolo orto. Gesù, fin dai primi capitoli, è carico di responsabilità non perché figlio di Dio, ma in quanto “uomo di casa”. «Mia madre, […] come tutte le donne con prole, era certa che suo figlio avrebbe cambiato il mondo. Ne avrebbe sconvolto la prospettiva, arrestato l’inerzia sterile del tempo che le sembrava fermo e immutabile. Nell’interesse di ciascuno ma soprattutto a beneficio di lei, la donna, la madre: suo figlio le avrebbe disegnato un nuovo destino».
E a proposito di destini: Calaciura, da un certo punto in poi, non fa che giocare con le nostre aspettative nei confronti della sorte, nota a tutti, del Gesù ufficiale. Ed ecco che, prima del previsto, fuori dalla sua storica giurisdizione, spunta Barabba, seguito da Erode Antipa, poi da Lazzaro, e così via: ogni capitolo aggiunge due piedi alla carovana di comparse eccellenti che, di fatto, ci sorprendono non facendo ciò che invece ci aspettiamo che facciano, fino alla stoccata decisiva, un colpo di scena commovente e, a seconda della prospettiva con cui si legge il libro, espiatorio – sì, insomma, niente spoiler, ma se dico “Vita di Gesù”, dopo la madre e parecchio prima della Maddalena, qual è il personaggio più disperato, quindi letterario, che vi viene in mente?
L’obiettivo dell’autore, però, non è soltanto quello di stupire scompaginando. Anzi. Riscrivere la storia di Gesù e trasformarla in un romanzo di formazione (o forse sarebbe meglio dire “di sostituzione”), significa, per Calaciura, donare all’eroe più popolare della cultura occidentale un substrato esperienziale che possa giustificarne la forza e l’ostinazione; cioè, più semplicemente, premettere all’effetto (noto) una causa (nuova, secolare). Operazione rischiosa – visto che pretendere di spiegare le ragioni di Gesù significa, in un certo senso, reinventare Dio, o riassegnarne la parte – eppure riuscita. Nel vestito di una scrittura più piana del solito ma comunque, da par suo, elegantissima, Calaciura ha confezionato un romanzo centrato, autorevole ed emozionante, nonché carico di sorprese.
L’ambientazione, in fondo, consentiva di tutto. Si veda, per una matrice, Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar, con cui Io sono Gesù condivide, oltre al personaggio storico che parla in prima persona, il contesto di passaggio tra il politeismo e, naturalmente, il cristianesimo. Una parentesi che ha incoraggiato, dopo Yourcenar, l’azzardo umanista di Calaciura. La prima volta che, nel romanzo, compare la frase «Padre, perché mi hai abbandonato?» Gesù ha diciassette anni, non trentatré, e sta pensando a Giuseppe. Nella mente di un giovane che deve tutto alle persone prima che alle scritture, al materiale prima che al divino, non c’è creatore più stupefacente di un papà falegname. «Mio padre che faceva miracoli con il legno, con le sue mani onnipotenti, che aveva sgrossato dalle radici ogni animale della Creazione per il mio divertimento». Di chi si parla? Vuoi vedere – suggerisce Calaciura – che Dio, stringi stringi, non è altro che l’educazione, l’accudimento, il modo in cui restituiamo l’amore che abbiamo ricevuto da ragazzi?
Dopo l’ultima pagina di Io sono Gesù ci si chiede se si sia letto, per usare un gergo mutuato dal cinema, un prequel o un reboot. Se, cioè, Calaciura abbia voluto coprire il vuoto (insolito, misterioso) sulla giovinezza di Cristo o proporre un ipotetico “in realtà è andata così”, una vicenda alternativa, inzeppata di riferimenti suggestivi alla storia ufficiale. Il finale, che contiene sorprese, offre la possibilità di convincersi di entrambe le letture — anche se, da un punto di vista finemente letterario, la seconda ipotesi è più divertente. Soprattutto perché apre a un altro dubbio, che ci riporta a qualche rigo fa: quale delle due storie sarebbe stata migliore per lui, per Gesù? Quella con Dio – quindi la letteratura, la grandiosità – o quella (apparentemente) senza Dio – quindi la sua vita di uomo comune, ragazzo e figlio innamorato, realisticamente individualista, disperato per ragioni personali?
Si è più felici da persona o da personaggio?
Questo bel romanzo sembra il tentativo di restituire a Gesù un po’ del suo altruismo, e la possibilità di preoccuparsi solo di se stesso, della sua casa, di sua madre; un’autorizzazione a essere felice, o almeno sgravato dalle responsabilità; un modo laico per dirgli, a nome della letteratura, “Scusaci”, ma anche “Grazie”. Perché Cristo, che soffre, muore e resuscita ogni volta che lo si racconta, è in fondo la dimostrazione che il romanzo può vincere sulla realtà: che sarà mai, per una volta, se uno scrittore ricambia il favore, salvandolo?
Nicola H. Cosentino (1991) è nato a Praia a Mare e vive a Cosenza, dove cura per l’Università della Calabria un progetto di ricerca su Michel Houellebecq e le distopie contemporanee. Ha esordito come autore pubblicando Cristina d’ingiusta bellezza (Rubbettino, 2016) e alcuni racconti per Colla e Nuova Prosa. Il suo ultimo romanzo è Vita e morte delle aragoste, uscito a luglio 2017 per Voland.






