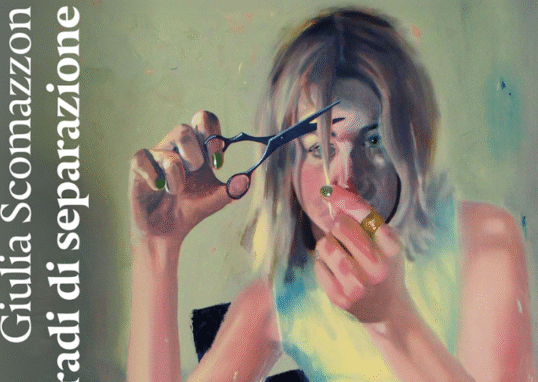Ricordiamo tutti la scena di Matrix in cui Morpheus, dopo avere rivelato, l’inganno monumentale sul quale si fondava la percezione e la natura stessa delle cose, rivolgeva a Neo la domanda più inquietante della storia, chiedendogli di scegliere tra la pillola azzurra (che preservava il segreto della consapevolezza) e la pillola rossa (che lo avrebbe riportato nel paese delle meraviglie): «What is real?».
Quella domanda, che nella sua semplicità ci appariva forse banale, di fronte all’enormità del fraintendimento che nella storia del film sottintendeva, probabilmente lasciò interdetti molti spettatori. E, in effetti, a ripensarci oggi dopo ventisei anni, esiste forse una definizione della realtà (al di fuori dei poco pervi enunciati filosofici) che la descriva con esattezza senza ricorrere alla tautologia; senza affermare – in altre parole – che la realtà è quello che è, il modo in cui le cose si impongono alla conoscenza, un’esperienza che per tutti è necessariamente la stessa cosa ma che, allo stesso tempo, per ciascuno è profondamente diversa? La realtà è lì davanti a noi, eppure scivola via senza riuscire a persuaderci del tutto, lasciandoci dentro un senso di eccessivo turbamento, un presentimento di qualcosa di orribile che insiste al di sotto della superficie delle cose. E la loro apparente naturalezza ci fa sentire in pericolo.
È quello che ci sembra di percepire leggendo qua e là alcune pagine di Flesh, il nuovo romanzo di David Szalay (ed. Jonathan Cape, 2025) non ancora tradotto in italiano. Il libro è pieno di affermazioni del genere, al punto che non possiamo dubitare che questo concetto sia una parte importante della poetica del romanzo. Prendiamo ad apertura di pagina: «C’è qualcosa di terribile nel modo in cui la normalità impone sé stessa. Nel modo in cui l’estate insiste nel manifestarsi. Nel modo in cui i castagni fioriscono e Wimbledon si svela».
Siamo a Londra, nella parte finale del libro. István, il protagonista, ha attraversato diverse fasi della vita, e ora ne sta terminando una importante. La madre gli sta parlando di questioni finanziarie da cui dipenderà il suo futuro prossimo, ma il narratore ritiene necessario iniziare il nuovo paragrafo con uno sguardo attento al paesaggio esterno. La differenza tra realtà esterna e percezione interna è uno degli aspetti più significativi del romanzo. István è un personaggio elementare, quasi fastidioso nella sua estrema semplicità. Le cose accadono e lui ne prende atto. Le conseguenze degli avvenimenti sembrano raggiungerlo sempre con un po’ di ritardo, soprattutto quelle più drammatiche.
I dialoghi che lo riguardano sono molto spesso estremamente elementari: «Is it okay?». «It’s okay», István says. Oppure: «Sure?». «Sure». O ancora: «Yeah?». «Yeah». E potremmo continuare. Per István sembra andare sempre tutto bene, anche quando non ne è sicuro, anche quando non gli sembra, anche quando non è vero.
All’elementarità forse eccessiva dei dialoghi, si contrappone il lirismo e la profondità con cui il narratore descrive il paesaggio esterno, che appaiono repentinamente sulla pagina con una evidenza poetica che spesso sorprende il lettore. Szalay sente la necessità di allontanare il punto di vista per mettere meglio a fuoco ciò che sembra sfuggire nella monotonia dei personaggi, per restituire alla storia un tessuto più fitto, a più dimensioni, che regga meglio la prova sfrangiata della soggettività: «Da lassù, Londra scintilla in lontananza. Più in basso, il fiume cattura la luce tranquilla dell’autunno e gli alberi grigi di Battersea Park sembrano presi dal modello presente sul tavolo, all’interno. C’è il mormorio tranquillo del traffico. Accende la sigaretta e sorseggia il caffè, ripensando alla sua interazione con il ministro della sera precedente».
A volte lo sguardo rivolto verso l’esterno offre un riparo al disordine che István avverte dentro di sé. Più spesso, l’apertura sull’ambiente esterno conferma le sue insicurezze, avvolgendole in una patina di incommensurabilità. Ciò che gli giunge da fuori appare minacciosamente astratto, non decodificabile in un’esperienza chiara. Anche le immagini apparentemente più rassicuranti sembrano nascondere un’insidia segreta. Risuonano a distanze inaccessibili, da cui possono giungere solo indistintamente, irrimediabilmente remote.
I lettini di plastica per prendere il sole accanto alla piscina sono rivolti verso quelle torri – quelle tre torri che sembrano punte dirette verso il cielo, con alcune sfere blu infilate su due di esse.
Apre gli occhi e le vede lì, a metà distanza, che puntano verso il cielo vuoto.
Di solito nel pomeriggio giunge una specie di sonno leggero.
I suoni in un mondo senza spazio assumono una qualità astratta.
Passeri.
Un elicottero che passa.
Voci a distanze diverse.
Qualcos’altro, non è sicuro cosa sia
Passeri.
Apre gli occhi e trova le cose diverse. Le ombre in posti diversi. La qualità della luce non è esattamente la stessa, più morbida, più opalescente, e una parte della piscina è in ombra, facendo sembrare l’acqua piatta e profonda in quel punto.
In questa descrizione, le parole sembrano private di un referente concreto, materiale. C’è un’evidenza, qualcosa che accade, ma niente sembra lasciare conseguenze importanti. Perfino i simboli (o – diciamo così – le metafore potenziali, le cose che in una narrazione potrebbero alludere ad altro) sono privati di un significato. Il cielo rimane vuoto. I suoni restano tra di loro irrelati, privati di un senso qualsiasi, pure e vacue astrazioni. La luce, anziché far risaltare le cose nella loro necessità, sembra quasi trasformarle in qualche cosa di diverso, di cui si inizia a dubitare.
Nel mondo esterno si percepisce una continua sfasatura tra ciò che appare e ciò che ci si aspetta. Non una vera e propria differenza, ma l’introduzione di una distanza che provoca un effetto di rifrazione. Quando una cosa è nello stesso tempo nel posto in cui si trova realmente e nel posto in cui noi la percepiamo, si innesca il processo del dubbio. La realtà ha davvero un perimetro delineato con esattezza? O si manifesta piuttosto come un’onda, qualcosa che non occupa uno spazio fisso ma uno in movimento? E se è così, cosa possiamo conoscere noi della realtà? Ha senso pretendere di conoscerla in un momento specifico, o l’unica esperienza che possiamo farne è un’esperienza estesa, in senso diacronico? E in tal caso, di quanto tempo abbiamo bisogno per conoscerla con un buon margine di approssimazione? E se la realtà è mutevole, come riusciremo a definirla con un linguaggio abituato a scattare delle istantanee, a raccontare singoli attimi?
Flesh racconta la vita di István in vari momenti della sua esistenza, che vanno dall’adolescenza alla maturità. Sono delle fasi molto diverse tra loro, in cui il protagonista ha condizioni familiari, sociali, economiche tra loro estremamente differenti. Ma in fondo, a parte una naturale maturazione dovuta all’aumentare dell’età, István non sembra cambiare davvero molto nel corso del libro. Continua ad avere un atteggiamento sostanzialmente passivo, e a sperimentare che le cose possono essere in un certo modo e al tempo stesso essere esattamente al contrario.
All’età di quindici anni, István ha un’avventura sessuale con una donna molto più grande di lui. Per lei si tratta di un semplice gioco, un’evasione spensierata da una vita che per lei, purtroppo, è molto complicata. Per lui – d’altro canto – è invece la scoperta della vertigine che il sesso rappresenta a quell’età, un’energia vitale che sconvolge completamente un individuo e lo induce a vedere ogni cosa sotto quella nuova lente che amplifica e deforma tutto.
A un certo punto István, depistato dalla propria inesperienza e dalla propria giovinezza, arriva a pensare che possa trattarsi di amore. E, con un candore commovente, un giorno lo rivela alla donna:
«Ti amo,» le dice il giorno dopo. Sono sdraiati sul letto di lui.
«Non dirlo,» dice lei.
«Perché no?» dice lui.
«Non sai cosa significa,» dice lei.
«Certo che lo so,» dice lui.
«No,» dice lei, accarezzandogli i capelli.
Lo fa arrabbiare il modo in cui lo fa. Sposta la testa.
«Perché lo dici?» le chiede. «Perché dici che non so cosa significa?»
«Tu non mi ami,» dice lei.
«Ti amo.
«Ti prego,» dice lei. «Smettila di dirlo.»
Molti anni dopo, István ha una breve relazione con la propria donna di servizio. L’uomo è in una condizione psicologica molto complicata. Da poco tempo, la sua vita è drasticamente cambiata, e l’uomo attende a breve un altro cambiamento ancora più importante. Per István quella storia non significa nulla. Per la donna invece, innamorata di lui probabilmente da molto tempo, è un sogno che si avvera, una felicità così grande da essere – ancora una volta – confusa con l’amore:
Lei continua a dire che lo ama.
«Smettila di dirlo,» le dice lui.
«È vero,» dice lei.
«No, non lo è,» dice lui.
Anche se questa volta è István a negare che si tratti di amore (e attenzione, non nega il proprio amore per la donna, ma l’amore della donna per lui, proprio come era accaduto, a parti invertite, nella sua adolescenza), è singolare il ritorno della sfasatura tra i due punti di vista. In entrambe le circostanze, nella coppia c’è qualcuno fortemente convinto di qualcosa, e qualcuno altrettanto convinto del contrario. Al punto che vieta all’altra persona anche solo di esprimere il suo punto di vista, e lo fa entrambe le volte utilizzando le medesime parole: «Stop saying that», «Smettila di dirlo».
La sfasatura non è per niente leggera. È praticamente un’opposizione. Da essa dipende la soddisfazione o il fastidio, la felicità o l’infelicità, la vita o la morte.
E ciò è ancora più vero quando la sfasatura non è tra l’interno e l’esterno di un personaggio, o nella relazione che esiste tra due personaggi, ma tra l’identità di una persona e la sua esistenza fisica, ovvero il proprio corpo.
Come suggerisce il titolo del romanzo, Flesh è prima di tutto un libro sul corpo. Non tanto come aspetto fisico dell’identità, quanto come carnalità, come spinta sensoriale e sessuale, un’entità che ha molto a che fare con l’identità stessa, ma che rimane – sostanzialmente – separata da lei:
Forse è a quell’età, pensa, che per la prima volta hai la sensazione che tu e il tuo corpo non siate del tutto identici, che occupiate lo stesso spazio senza essere esattamente la stessa cosa, perché una parte di te sembra rimanere indietro rispetto alla trasformazione del tuo corpo, e ti sorprendi di ciò nello stesso modo in cui potrebbe farlo un osservatore esterno, tanto che non ti senti più completamente in sintonia con il tuo corpo come lo eri sempre stato fino ad allora, e comincia ad avere senso parlarne come se fosse qualcosa di leggermente separato da te, anche se ti senti più impotente che mai nel negargli ciò che vuole.
Non solo il corpo è una parte leggermente separata da lui, ma è più forte di lui. Szalay sembra qui rovesciare completamente il senso dell’affermazione evangelica «The spirit is willing, but the flesh is weak” (Mt., 26, 41). Non solo la carne non è affatto debole, ma anche lo spirito non è per nulla determinato (willing), quanto impotente (powerless), ovvero privo di qualsiasi potere.
Per István la carne ha desideri che determinano quasi sempre il corso della sua vita, per cui verrebbe da pensare che il suo corpo non sia un attributo della sua vera identità, ma che, al contrario, sia la propria identità a essere un’emanazione del proprio corpo. E la presunzione di essere in grado di compiere delle scelte indipendenti dal corpo è solamente un’illusione. L’identità di un individuo non ha potere contro i desideri del corpo. Può soltanto prendere una forma intorno a quei desideri. Ma è una forma presa in prestito, il cui perimetro – non possiamo dimenticarlo – è leggermente sfasato rispetto alla sua posizione reale.
Ed è per quella sfasatura, per quella fessura impercettibile, che passa la forza che solidifica la storia.
Luca Alvino è nato nel 1970 a Roma, dove si è laureato in Letteratura Italiana. Nel 2025 ha pubblicato per Il Convivio la raccolta poetica Sono il poeta. Nel 2023 ha tradotto e curato per Interno Poesia un’ampia antologia delle poesie di John Keats, intitolata Mio cuore. Nel 2021 ha pubblicato, ancora per Interno Poesia, la raccolta poetica Cento sonetti indie. Nel 2018 è uscita per Castelvecchi la sua raccolta di saggi Il dettaglio e l’infinito. Roth, Yehoshua e Salter. Nel 1998 ha pubblicato con Bulzoni una monografia sull’Alcyone di Gabriele d’Annunzio, intitolata Il poema della leggerezza.