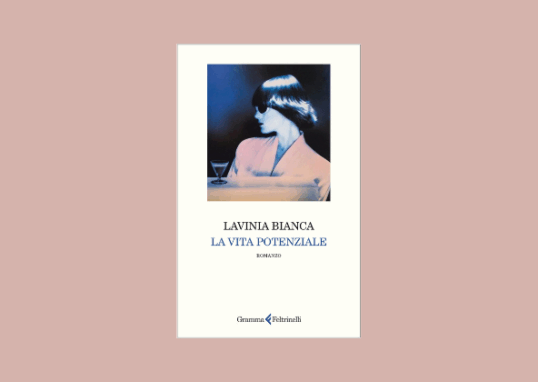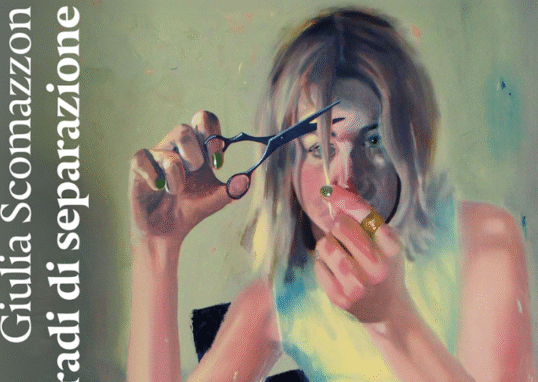Con Il figlio delle sorelle (Ponte alle Grazie, 2022) Leonardo G. Luccone esplora la deriva di un uomo senza nome consumato dal tormento, incapace di orientarsi nel groviglio di pensieri guasti. Non sa guardarsi vivere, provare ribellione e rabbia. Avanza nell’esistenza per esaurimento di volontà, ammantato da una solitudine che intride ogni impulso residuo. Tre atti – La salita, La discesa, Convivio – marcati dalle parole di Johann Wolfgang von Goethe, Ralph Waldo Emerson, Vincent Vega, Evelyn Evelyn; quindici personaggi, incluso il coro di voci che assillano il protagonista; due spazi – Roma e la Sicilia – e una tessitura drammaturgica dai dialoghi serrati che evidenzia traumi, morbosità e conflitti consumati nel presente (il 2018) originati da un passato che risale agli ultimi scampoli del Novecento.
Un affaccio sull’irreparabile apre il romanzo. Attorno a quel protagonista senza nome che anela di liberarsi dal peso del vivere prende forma un tetro carosello che tradisce un disagio esistenziale diffuso. La causa apparente è la fragilità di una coppia di fronte alla decisione unilaterale di avere un figlio. Il buio legato a quella nascita corrode un uomo che si mostra incapace di far fronte al proprio male oscuro diventando un padre assente, invisibile, annientato. La fine del matrimonio con Rachele coincide con la nascita della figlia Sabrina. Lo straziante ricordo della fine accompagnerà l’uomo anche nella convivenza con la nuova compagna Gilda e la figlia Carlotta.
La vicenda avanza per graduali disvelamenti, procede per abbagli, mistificazioni del reale. L’origine del delirio è nella cristallizzazione dell’attimo che rende quel passato tormentato un presente sospeso. Tra soliloqui e conversazioni monche, riaffiora la traccia di una ricerca: l’innominato protagonista si rivolge alla donna ritenuta artefice di quell’inabissamento. Il senso di gratitudine che egli nutre nei suoi riguardi lo ha reso per lungo tempo sottomesso al suo volere annullando ogni proposito. L’urgenza di risposte invade anche chi si affaccia all’età adulta con l’esperienza dell’abbandono paterno e con la necessità di riabilitare un padre provando ad allestire un “corredo di ricordi seminuovi”.
Sfilano sulla pagina donne segnate dal trauma; Sorelle Felicità dal travestimento inquietante; ragazze che provano a immaginare una direzione nuova attuando rimozioni selettive o riscrivendo la storia recente tra strazi e fugaci euforie. Volti diversi accomunati dall’avanzare incerto in un’esistenza rimodulata da un doloroso spartiacque.
Luccone conduce il lettore nei meandri di un assillo radicato e irrisolvibile, generato dal tarlo dell’incomprensione e risolto nell’abulia. Attraverso flashback, reiterazioni ossessive, flussi di coscienza e inganni della memoria, il lettore prova a comporre una storia per poi scoprire di trovarsi di fronte a una delle innumerevoli versioni della realtà, nel perenne miraggio di una verità inafferrabile. Gli indugi descrittivi assegnano a particolari minimi potenti simbologie, accertano lo stato di una deriva privata. L’orrore che incombe trova uno spazio a parte nella narrazione, una raffigurazione che diventa via via più nitida nell’intrico di pensieri apparentemente illogici che attanagliano il protagonista e nutrono la sua disperazione.
Il figlio delle sorelle rivela una natura audace e sovversiva che guarda al romanzo europeo del primo Novecento per reinventarne i moduli espressivi. La figura collocata al centro dell’opera cela la propria scissione interna, un’estraneità al contesto che produce smarrimento. In tale assenza di certezze i contorni del noto sfumano nell’allucinazione, allagano le terre riarse della memoria.
Niente era più mio. Il cuscino cambiava morbidezza ogni notte, non ritrovavo mai la stessa tazza del latte e caffè; nella dispensa non c’erano più i pacchi di pasta che avevo comprato, né gli yogurt in frigorifero. Solo sul ripiano del miele trovavo la mia stabilità.
L’allestimento del paesaggio urbano, la concezione di una casa come assedio e rifugio, la costruzione di una zona franca in macchina di fronte a un Moscow Mule, aderiscono solo in parte alla raffigurazione del tangibile, tracciano un’individualità complessa e indecifrabile avulsa dal mondo intorno. La prosa di Luccone affonda nei meccanismi del caotico fluire di una confessione con slanci lirici che anticipano l’ineluttabile, annunciano un dramma che continua a consumarsi nella corrosione lenta dell’identità personale.
Dalla finestra della mia camera vedevo il filo del bucato teso, i pali cigolanti tutti inclinati. Quando c’era vento, l’armonia metallica smembrava il vuoto.
L’architettura del romanzo imbastisce lo straniamento, racconta la scelta di identificare il cardine in un elemento all’apparenza marginale: le voci che assillano e annientano il protagonista. Gli schiamazzi della follia serbano la verità, come insegnano le tragedie shakespeariane: traducono il movimento perché sono l’esito di un’inarrestabile evoluzione. Un vortice oscuro risucchia il lettore, impedisce emersioni, si fonda su un flusso verbale incontrollato: un divenire lessicale basato sul tradimento. Ogni parola custodisce la precedente e al contempo la contraddice, la deforma. Gli stravolgimenti di senso generati da alterazioni minime producono nuovi significati. Sono i giochi verbali, le assonanze, le metamorfosi lessicali a comporre una sinistra melodia del dramma in quell’incontrollata amplificazione semantica. Aspetto determinante per interpretare un’opera complessa che trova nella misura del romanzo breve una breccia per affacciarsi sull’assurdo, narrare l’insensatezza del vivere e farlo identificando nella lingua il mezzo di una profana annunciazione.
VOCE: Nella testa hai solo sbucciature. Nella testa hai solo trucidature. Nella testa hai solo mancature. Solo troncature. Smangiucchiature, tramature, stancature, sbavature, sporcature, strozzature, smerigliature, annaspature, sgommature, abbandonature. Abbandonature.
La cifra espressiva è riconoscibile nelle variazioni potenzialmente infinite di una parola-tema che diventa parola-sentenza tra figure drammatiche che ricordano quelle costruite da Thomas Bernhard nel raccontare il dilagare della tragedia in contesti famigliari apparentemente inamovibili. Un’eversione fondata su un impianto formale che colloca al centro l’esondazione linguistica e emotiva di un coro che sostanzia il tormento, e rende gli eventi narrati il margine incompleto e aperto di una storia che non si mostra nella sua interezza.
Affascinato dall’ambiguità, dall’inganno del visibile, Luccone compie un’esplorazione sensibile di luoghi raccontati nel sentimento che sprigionano: la sottile malinconia evocata dal ricordo di un istante qualsiasi appartenente a un quotidiano irripetibile; l’angustia insita nel nome esotico di una clinica psichiatrica a San Felice Circeo; l’inquietudine di uno spettacolo naturale che cela l’incompiuto. Il luogo è tracciato dalla parola, una stanza immaginaria in cui un padre e una figlia si incontrano per lasciare ogni difesa. Lo spazio è il tempo indefinito di uno squilibrio perpetuo, contestualizza una crisi che invade ideali, convinzioni, attitudini, manie, tediose consuetudini, affanni.
Ogni descrizione, con l’apice raggiunto nell’ammaliante e ambiguo ambiente siciliano tra asfodeli, gigli, narcisi, giacinti in una primavera perpetua, si offre come un immaginario possibile, un paesaggio che si raffina e che si compie con il volto dell’amato, come sosteneva Gilles Deleuze. Quel presente costellato di buchi e falle accoglie un viaggio che diventa esperienza iniziatica, coinvolge in modo totalizzante un padre e una figlia smarriti nelle rispettive incertezze. Assegna a quella giovane donna il compito di interpretare i simboli che la circondano nel prendere consapevolezza di essere parte di un rito e scorgere il radicamento di quella storia nel mito, tra fiori intoccabili, ombre, bambini nelle ceste, canti di donne, latte di serpenti, spighe in tasca. Più che come allegorie, le immagini costruite sulla pagina si propongono come indizio per esortare chi legge a scoprire la traccia sotterranea che lega le storie.
Il tempo si ripiega dentro di me, mentre le onde della sofferenza si sparpagliano indisturbate, la memoria avvelenata agogna un passato di comodo. Il buio è fatto di sogni sporchi e copioni – distese di parole e immagini rinsecchite a testimonianza delle troppe possibilità della lingua.
Il rilievo de Il figlio delle sorelle risiede in una costruzione che riserva un fondamentale richiamo: l’equilibrio sottile e perfetto tra disgregazione e edificazione. Un’opera che travalica la vicenda del singolo per interrogarsi sulla labilità dell’esperienza esistenziale, sulla falsificazione perpetua e sul ridicolo che caratterizza la natura umana. Un elogio della vita come mirabile farsa, vano addestramento alla resistenza.
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.