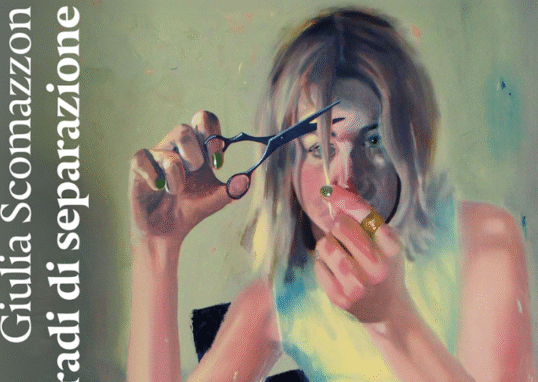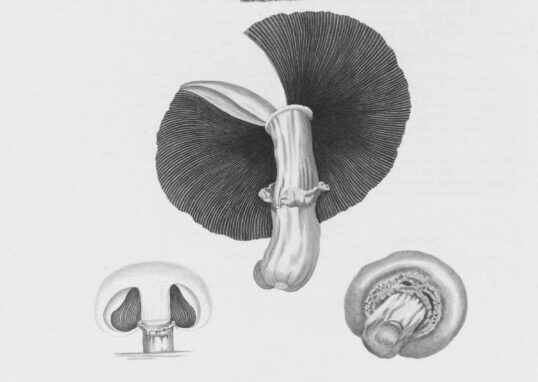«Scrivo in un soggiorno semivuoto. Mi fanno compagnia una lampadina, un tavolo blu, un computer, un materasso, una candela, una sedia a dondolo. Quando dal tavolo blu cade una penna, schiantandosi sul parquet produce un’eco».
Ci si sente come dopo aver finito di leggere un bel libro di poesia, o come quando si arriva davanti al mare dopo una lunga passeggiata, ed è estate, ed è inverno. Ci si sente come dopo aver ascoltato un monologo a teatro. La scena quasi spoglia, la voce dell’attore, le luci basse, ombre, una musica costante in sottofondo. Costante e distante. Ci si sente come quando qualcuno – una persona cara – scompare o muore, e bisogna mettere le mani tra le sue cose, provare a scomporre e a ricomporre, a dover scegliere tra cosa tenere e cosa dare. Che cosa nascondere. Ci si sente come quando di colpo si è soli, e quello è l’inevitabile destino, e quella è l’unica paura. Ci si sente in coda a tutti gli amori grandi che finiscono, perché non finiscono mai, ci si sente così perché gli amori stanno già nelle cose, nemmeno iniziano.
Sono un discorso già cominciato, un bacio nato prima di pensarlo, stanno su una strada che non chiude mai, sempre illuminata a giorno. Si entra in un ritmo e si avverte un brivido, si prende parte, si entra come in un abbraccio privato, in un dolore, in una lunga commozione, si entra e non si deve capire, ma leggere. Queste cose avvengono al cospetto di I dieci passi dell’addio di Luigi Nacci (Einaudi, 2024).
Ti sembra che le cose che fanno schifo facciano meno schifo. Una persona amata fa bene a tutto ciò che esiste.
Questo libro è il racconto della fine di una storia d’amore, ma anche dell’impossibilità che un amore concretamente possa finire, perché nessuno saprebbe dire quando tutto è cominciato. Una se ne va e prima ancora che si arrivi dal notaio se ne vanno le cose. Gli oggetti, gli odori, i sorrisi, le speranze condivise. Allo stesso tempo, le stesse cose rimangono, chi racconta non vuole che se ne vadano. Tutto deve sparire, forse, per poter ricominciare; tutto deve restare perché è stato troppo importante e meraviglioso per scomparire. Luigi Nacci scrive un racconto molto poetico, del resto è un poeta, e poi un racconto su come le distanze diventino infinite e poi tornino minime, del resto è un camminatore. Soprattutto, Nacci è capace di sguardo, di visione sui giorni, sugli attimi, e pensa che tutto sia respiro e chi vorrebbe che questo respiro, proprio in questo momento, proprio quando la porta si chiude, chi vorrebbe che sia l’ultimo?
Devo fare da me, non devo chiedere aiuto a nessuno. Non devo fare nomi. Ci siamo solo io, lei, il dolore e l’amore.
Qualcuno è in una casa ormai una vuota, una casa che sembra un bivacco, scatoloni qua e là, oggetti che non hanno più un nome, che sono altro da loro, sono una pagina da voltare che non è voltata, che sta lì a mezz’aria con il dito che non riesce a compiere l’ultimo movimento. Allora bisogna consegnarsi all’addio, bisogna trovare il modo. Il modo del narratore è di rinominare le cose. La camera, la cucina, l’armadio, tutto deve avere un nome nuovo. Mentre tutto crolla cerchi il punto ancora in cui un momento splende, e brucia. Ti siedi al tavolo e scrivi, scrivi l’addio in dieci passi, dieci movimenti, che tagliano e rammendano, che feriscono e suturano, che strappano ma mai del tutto. L’addio che Nacci recita, come un mantra, come una preghiera, come una memoria che sbiadisce ma non svanisce, è l’unico addio possibile all’amore, un addio destinato a non compiersi, solo a trasformarsi, un addio che sostituisce il sorriso con una schiena, un addio che abbandona ma che non dimentica. Un addio vero, come si deve.
Resta solo tra le cose il protagonista, e la colpa di questa solitudine è la sua, non si condanna perché condanna non c’è, le cose vanno come devono andare e il dolore è tra le cose, come l’amore. La domanda è: un amore grande può davvero finire, svanire? La risposta di Nacci è no, ed è anche la nostra. Lo si può solo accompagnare altrove, come quando metti una cosa in un cassetto, una cosa cara, quel cassetto non lo aprirai più, ma sai che c’è, sta lì in soffitta, in garage, in un’altra stanza, che era il salotto e che ora è soltanto di là.
Ho scritto tante lettere d’amore nella mia vita. Sono la cosa migliore che ho fatto.
Una poesia molto bella di Luigi Nacci di qualche anno fa recitava: Avrai poche cose ma quelle le avrai, il verso apriva una serie di strofe e si snodavano oggetti, immagini, sguardi, scene. Parla in balcone ai girasoli, leggevamo a un certo punto, ed è questo che fa il protagonista di questo romanzo. Parla ai girasoli di stanza in stanza, lo sa che appassiscono, ma sa che il colore che una volta è stato così luminoso non può sparire, sa che l’odore rimane. Ogni cosa rimane, giorno dopo giorno, proprio mentre se ne va.
I dieci passi dell’addio è un libro bello, poetico e commovente, lo si legge in meno di due ore, ma poi ci si torna per sottolineare meglio un passaggio, per farne memoria.
Gianni Montieri, è nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per Doppiozero, minima&moralia, Esquire Italia, Huffpost e il manifesto, tra le altre. Prova a incrociare la letteratura con lo sport per L’ultimo uomo, Rivista Undici. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Ha pubblicato per 66thand2nd due titoli Il Napoli e la terza stagione e Andrés Iniesta, come una danza. Vive a Venezia.
Altre info qui:
https://giannimontieri.wordpress.com/biografia/