
di Mirko Alagna
Brinda, chiacchiera, gioca e brinda di nuovo Franz Ferdinand Trotta; lui e la sua combriccola viennese puzzano di Ottocento e antico regime, sono anacronistici e fanno di tutto per non accorgersene, per non vedere la morte che incombe – letteralmente: come una litania, ad ogni brindisi del giovane Trotta compare la frase di rito: «la morte incrociava già le sue mani ossute sopra i calici dai quali bevevamo» (J. Roth, La Cripta dei Cappuccini, Adelphi 2011). La giovane aristocrazia della felix Austria va alla Grande Guerra con un misto di indolenza e rassegnazione: sente che sarà la fine del mondo, ma in fondo sa che quel mondo è già finito. Come il suo Imperatore – vecchio, stanco, malato, fuori posto –, l’intero Impero con la sua nobiltà, la sua mollezza e i suoi caffè è il residuo eccentrico di un’epoca tramontata.
Di qua dalle Alpi l’atmosfera è diversa, almeno per alcuni. La Prima Guerra Mondiale appare come il parto di sangue di un mondo nuovo da cui c’è tutto da guadagnare – insieme ultimo atto dell’Indipendenza e prima prova di un giovane Regno con manie di grandezza tanto evidenti quanto evidentemente malriposte. Carlo Emilio Gadda, non ancora gran lombardo (ha solo 23 anni) né ingegnere (è ancora studente), parte volontario e per 51 mesi sarà alpino, sottotenente prima e tenente poi, mitragliere sul Carso, sconfitto a Caporetto, prigioniero in Germania. Questi 51 mesi sono raccontati in presa diretta nel Giornale di guerra e di prigionia, diario personale del giovane Gadda sive Gaddus Duca di Sant’Aquila – un testo la cui storia editoriale è già di per sé romanzesca, come ricostruito da Paola Italia in coda all’ultima, aggiornatissima, edizione Adelphi. Sbrighiamo subito l’aspetto che oggi può risultare più urticante o perlomeno distante dalla nostra sensibilità, e togliamoci il pensiero: Gadda, come detto, parte volontario e intriso di patriottismo per la guerra «necessaria e santa» (p. 123), e necessaria e santa continuerà a ritenerla per tutto il tempo, senza sbandamenti; nessuna redenzione o ravvedimento, non ci si aspetti il copione canonico, da romanzo di formazione, della disillusione traumatica o del progressivo disgusto per la mattanza. Per 51 mesi vuole l’azione e la prima linea: smania quando è costretto alle retrovie, cerca in tutti i modi il fronte, è devastato dall’immobilità della prigionia, dai combattimenti che proseguono senza di lui, programma la Libia e un’altra guerra; bestemmia e sputa bile contro vigliacchi e imboscati, e ha il terrore di essere scambiato per uno di loro: non ha prove, non ha ferite, chissà dove sono finiti i suoi alpini, come potrà dimostrare che si è battuto, che non ha tremato, che non si è arreso per salvarsi la pelle, che mille e mille volte avrebbe preferito la trincea e le bombe?
Il diario di Gadda è straziante perché straziato è lui; non è la macelleria di massa a colpire – i cadaveri sono pochissimi, e descritti con la precisione e freddezza dell’anatomista – quanto piuttosto i dolori, costanti, del giovane Gadda. Dolori fisici – l’intestino, soprattutto, non gli dà pace, e le notti sono spesso agitate – e sofferenze psichiche: Gadda scrive spellato (questa l’aggettivazione, perfetta, di Pedullà), attraversa il mondo con la carne viva continuamente esposta: piccoli fastidi e minuscoli dispiaceri – la battuta di un commilitone, un contrattempo, la polvere – gli provocano dolori lancinanti e insopportabili; le descrizioni e il racconto piano della quotidianità si interrompono di colpo con eruzioni di pura rabbia e frustrazione, come conati di vomito in cui si mischiano invettive, minacce, bestemmie, insulti. Non c’è gradazione, i nervi tesissimi di Gadda portano tutto subito all’eccesso: l’idiozia dei generali, le forniture inadeguate, «quello scemo balbuziente d’un re» (p. 40), la normalità di Milano quando a un passo c’è la guerra, le mosche – «le più puttane troie scrofe merdose porche ladre e boje forme del creato» (p. 160) –, il maggiore Mazzoldi – «lo sputacchierei e colpirei a calci nella vescica fino a vederlo sfigurato» (p. 46) –, i soldati che nemmeno si curano di individuare un luogo che faccia da latrina «riempiendo di merda tutto il terreno» (p. 136), le insolenze di un Nugari qualsiasi; tutto lo irrita allo stesso modo, ossia tantissimo. Gadda soffre di tutto, in primis della propria stessa sofferenza: maledice la «sensitività morbile» (p. 123) che lo accompagna e lo rende così suscettibile e inadatto alla vita, sa che per rovinargli giorni notti e digestioni è sufficiente «un disappunto, una debolezza, […] il disordine della mia camera o il ricordo di un male sofferto» (p. 86); ripercorre ossessivamente ciò che ha detto e ha fatto ingigantendo ogni dettaglio, studiando possibili interpretazioni, immaginando possibili fraintendimenti su cui poi si arrovella, disperato. Sperava che la guerra portasse ordine, invece «tutto è pasticcio, disordine e confusione» (p. 35); sperava che la guerra lo indurisse, invece torna a casa ancora più scorticato.
Il disordine lo avvilisce, più ancora: lo annienta (p. 160). Gadda ingegnere in pectore sembra sicuro, si aggrappa alla convinzione che tutto nel mondo abbia, debba avere, un suo luogo, un suo posto, una sua funzione che linearmente e ordinatamente si appoggia e si collega alle funzioni svolte dagli altri enti, oggetti o persone che siano; le cose ordinate sono chiare e comprensibili, ma soprattutto si sostengono e si aiutano e si incastrano senza forzature in un mosaico senza soluzioni di continuità. L’ordine è un principio di relazione e la relazione è principio di definizione: un tetto è ciò che ripara qualcuno o qualcosa dalla pioggia, è cioè definibile e individuabile proprio in virtù della relazione corretta e ordinata che intesse con la pioggia e con chi dalla pioggia è coperto; ma se l’acqua entra e tutto si bagna allora quel tetto è ben più che inutile: come lo si può chiamare ancora “tetto”, non si capisce più nemmeno che cosa sia. Gadda va alla guerra e si ritrova in un groviglio (sic!): «io che mi sono immerso con gioia nelle bufere di neve dell’Adamello, perché esse bufere erano nell’ordine naturale delle cose e io in loro ero al mio posto, io sono atterrito al pensiero che il soffitto del mio abituro sgocciola sulle mie gambe: perché quella porca ruffiana acqua lì è fuor di luogo, non dovrebbe esserci: perché lo scopo del baracchino è appunto quello di ripararmi dalle fucilate e dalla pioggia. – Sicché, per non morir nevrastenico, mi dò all’apatia» (p. 160). Ma lo stoicismo non è nelle corde di Gaddus, e appena tre giorni dopo ecco altri «pasticci», altra confusione, altre insensatezze e quindi altra rabbia lacerante: «Quand’è che i miei luridi compatrioti di tutte le classi, di tutti i ceti, impareranno a tener ordinato il proprio tavolino da lavoro? a non ammonticchiarvi le carte d’ufficio insieme alle lettere della mantenuta, insieme al cestino della merenda, insieme al ritratto della propria nipotina, insieme al giornale, insieme all’ultimo romanzo, all’orario delle Ferrovie, alle ricevute del calzolaio, alla carta per pulirsi il culo, al cappello sgocciolante, alle forbici delle unghie, al portafogli privato, al calendario fantasia?» (p. 163-164). Burocrati che non amministrano, generali che non sanno comandare, soldati che non vogliono combattere: Gadda è un fiume in piena, travolge e insulta tutto ciò che incontra perché nulla è al suo posto, nessuno fa ciò che deve: e il verbo modale indica qui la definizione grammaticale, non chissà quale imperativo morale. Anche i soldati – sì, anche per loro nessuna pietà – che ingialliscono al rumore del cannone, che si nascondono per «paura personale, paura di me, paura di io, paura di esso Io, del proprio Io, del proprio Io-me […] che il diavolo li scoglioni» (p.164). Il punto non è l’eroismo, la bella morte o chissà quali altre ridicolaggini retoriche: è sempre il disordine, è il disordine che tormenta Gadda: il soldato che non combatte è come un tetto che non ripara dalla pioggia – e quell’Io ipertrofico, che più tardi verrà bollato come il più lurido dei pronomi, appare come forza disordinante che spezza e scavalca ogni relazione.
La disfatta di Caporetto è l’epopea della confusione: gli ordini si susseguono contraddittori, i canali di comunicazione saltano, il tenente Gadda piazza le sue mitragliatrici ma non sa dove sono italiani e dove gli austriaci; parte la ritirata, girano notizie false, altre sono vere ma chi può saperlo; nervosismi, idee folli, tentativi alla cieca, disperazioni; sull’altra sponda dell’Isonzo una fila di soldati neri: sono i nostri! grida Gadda, e invece erano tedeschi. Finisce così la guerra di Gadda, con l’attraversamento – da prigioniero – dell’abitato di Caporetto: nella sua penna si trasforma in una sorta di presepe tragico, insieme cupo e dolcissimo, un presepe dello sconforto, del caos, del pasticcio: sul ponte due cadaveri «con le vesti e le carni lacerate, enfiate, chiazzate dalla putrefazione incipiente. E lì assi, cassette, rottami […]. L’Isonzo mugghiava sotto, nel letto profondo. – Poco avanti v’erano sparse sulla strada delle cassette di ufficiali, dei viveri, delle botti […]. Un soldato nostro ubriaco spillava vino da una botte aperta e il cui contenuto era in parte riuscito ad arrossare il polverone della strada» (p. 327).
La morte incrociava già le sue mani ossute sopra i drammi, i racconti, i sogni e le bestemmie del giovane Gadda; tornato a casa nel gennaio del 1919 viene a sapere della morte di Enrico, il suo fratellino, Enricotto, abbattuto in combattimento con il suo aeroplano: quel singolo morto che non è diluibile nel conto dei milioni di caduti. Enrico morto, la sorella malata, la madre distante, amata e irritante. Le ultime pagine del Giornale sono atroci: «molte cose non potrò esprimerle con l’intensità che vorrei, perché il dolore prostra, vuota, abbrutisce, distrugge, come dell’acido solforico versato sull’anima» (p. 518); nulla sembra degno di nota o interesse, nulla merita passioni o investimenti: nulla conta se Enrico non può vederla. In fondo, anche la morte è a suo modo una forma di disordine, la fine di ogni possibile definizione in quanto taglio di ogni possibile relazione: «la morte gli apparve, a don Ciccio, una decombinazione estrema dei possibili, uno sfasarsi di idee interdipendenti, armonizzate già nella persona. Come il risolversi d’una unità che non ce la fa più ad essere e ad operare come tale, nella caduta improvvisa dei rapporti, d’ogni rapporto con la realtà sistematrice» (C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Adelphi 2018, p. 73).
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

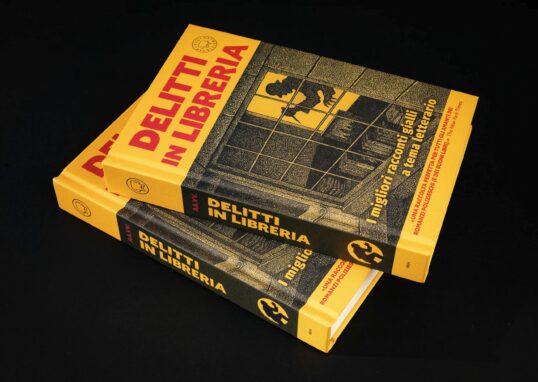





La lettura di questo giovanile capolavoro è indispensabile per capire la prima guerra mondiale, oltre che tutta l’opera letteraria di Gadda che verrà di seguito.
I miei scrittori preferiti sono ingegneri (o chimici, come nel caso di Canetti)