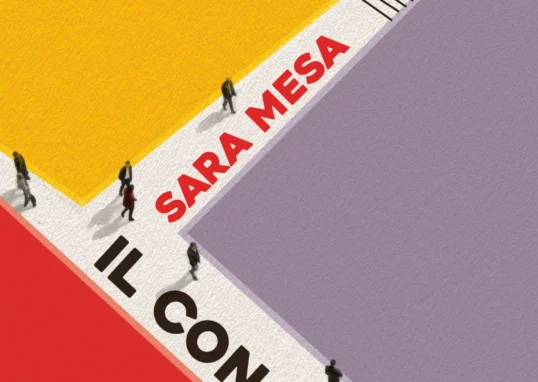di Giorgia Esposito
Ci sono città letterarie che diventano seconde case dello spirito. I loro nomi sono le parole, la stringa di lettere – Comala, Jefferson, Macondo, Santa Teresa, Santa María – che basta evocare per abitare la geografia e la coscienza di quel mondo possibile. Adesso abito anche a Obaba, e nutro un insolito sospetto per i ramarri.
Obaba è un’isola che non è un’isola, vale a dire, è un’isola per ostinazione e destino, non per morfologia, ed è anche un villaggio, un minuscolo punto sulla mappa laddove il mondo prende il nome di Euskal Herria. Nelle remote sere in cui la pioggia aiuta a ricordare, sono a Obaba. Quando penso che, sebbene tutte le belle storie siano già state scritte, bisogna continuare a scriverle perché altrimenti gli uomini e le donne dimenticano, sono a Obaba. Se guardo indietro e non vedo un filo conduttore né un paesaggio ben definito bensì un vuoto costellato di ricordi come un mare di nulla con qualche isola, sono a Obaba. E quando mi capita tra le mani quella vecchia foto di classe scattata in quinta elementare in cui ogni viso paffuto, malizioso o distratto tradisce palesemente il destino insospettabile o banale che verrà, sono a Obaba.
Nel Dizionario dei simboli, alla voce “Città”, Juan-Eduardo Cirlot associa la fondazione di una città alla fondazione di una dottrina, così la città diventa un simbolo di quella dottrina e, al contempo, della società disposta a difenderla.[1] In tal senso, il villaggio di Obaba – lo scenario su cui si iscrivono le vicende narrate in Obabakoak (Bernardo Atxaga, 21 Lettere, 2020)[2] – è metafora di provincia recondita costellata di personaggi pettegoli e schivi, desolanti o luminosi, ma è simbolo pure di un progetto letterario e politico più ampio, a tratti parossistico: riscattare e sublimare quelle isole nel mare di nulla, ossia fondare il canone della letteratura basca. Fondarlo a tutti i costi, anche sul plagio; non in virtù di un disegno machiavellico di nazionalistica ispirazione, bensì come atto d’amore diretto ai giovani scrittori baschi affinché possano attingere a un numero di libri sufficiente a creare un costume, un linguaggio letterario (p. 436). Questo perché la scrittura è un’operazione artificiale e il linguaggio letterario si forma con il tempo e con il lavoro di molte persone, secondo le esigenze espressive delle varie epoche. Una delle idee che soggiacciono alla fondazione di Obaba, dunque, è il riscatto di una tradizione linguistico-letteraria che liberi dall’invisibilità alcune parole, come ad esempio “replicò” (arrapostu), parole che per il lettore basco sono come un albero che conosce ma che non ha mai visto in un viale. Così, le storie che attraversano Obaba sono innanzitutto dei percorsi a ritroso alla ricerca dell’innesco, dell’antecedente:
Quello che ci mancava da imparare era “l’antecedente”, ci mancavano i libri sui quali imparare a scrivere nella nostra lingua. Pollicino non era passato sul nostro cammino: impossibile cercare le briciole di pane che avrebbero dovuto portarci a casa. (p. 435)
Eppure, Obabakoak non è certo un saggio o un pamphlet sul canone e sul linguaggio letterario basco; sostenerlo sarebbe non solo inesatto ma addirittura disonesto. Allo stesso tempo, chiamarlo romanzo sarebbe improprio, e raccolta di racconti ambientati a Obaba, riduttivo. Il libro si iscrive nella stessa tradizione del Decameron, Le mille e una notte e Manoscritto trovato a Saragozza, opere con cui condivide la centralità di una cornice narrativa all’interno della quale sono incapsulati racconti in apparenza autonomi ma via via sempre più interconnessi. In questo senso, le storie di Obaba si susseguono, avanzano in cerca dell’ultima parola mentre (o grazie al fatto che) deviano per tornare indietro, in cerca dell’origine, o per imboccare un sentiero strampalato, in cerca dell’analogia o del miraggio. Del resto, la memoria è come una diga, che dà vita al nostro spirito e lo irrora e, proprio come una diga, la memoria non ha un flusso lineare, al contrario, ha bisogno di canali di scolo per non straripare (p. 132).
Una delle caratteristiche della letteratura spagnola in lingua castigliana è la tendenza al realismo: ogni Don Chisciotte ha il suo Sancho Panza. Diversamente, la letteratura basca, che conta soprattutto su un’ampia tradizione orale, accoglie anche l’elemento fantastico, soprannaturale, allucinatorio. Così, in Obabakoak può accadere che gli esiliati della comunità siano un ragazzino che si trasforma in un cinghiale bianco che semina il panico nel villaggio oppure un poeta nano che si crede un nobile decaduto e vive relegato nella vecchia città tra edifici fantasma e volumi di etimologia. O ancora, accade che le favole tramandate di generazione in generazione ai bambini per metterli al riparo dalle insidie del bosco penetrino nella realtà ingarbugliandola.
A mano a mano che ci avviciniamo al centro di Obaba e all’ultima parola, nella terza parte del libro, i racconti sono sempre più interrotti e sospesi: il finale è mutilato, rimandato o moltiplicato. La lettura diventa un’operazione attiva, il processo di scrittura è rivelato, la buona novella del plagio (p. 361) finalmente è annunciata, con dovizia di particolari sui metodi da seguire e sulla difesa da preparare. Il lettore è dotato di un arsenale semiserio di strumenti che gli consentirà di passare all’atto creativo, alla scrittura di un racconto in soli cinque minuti, per il cui compimento:
È necessario che ascolti musica, qualunque canzone con il testo a lei incomprensibile: per esempio, una canzone russa. Ciò fatto, si ripieghi su se stesso, si morda la coda, guardi attraverso il suo telescopio privato il luogo dove le sue viscere lavorano silenziose, domandi al suo corpo se ha freddo, se ha sete, freddo-sete o qualunque altro tipo di angoscia. […] Si lasci trasportare dall’istinto, e immagini che lei, proprio lei sia un Golem, un uomo o una donna fatto di parole, o meglio, composto da segni. Faccia in modo che quelle lettere che la compongono escano per incontrarsi – come le cartucce di dinamite che esplodono per simpatia – con le loro sorelle, quelle sorelle dormiglione che riposano nel dizionario. (pp. 299, 300)
_
[1] Il Diccionario de símbolos di Juan-Eduardo Cirlot si può consultare in lingua originale qui: http://docshare02.docshare.tips/files/20368/203689084.pdf
[2] Pubblicato in lingua basca nel 1988, l’anno seguente è autotradotto in castigliano dall’autore, Bernardo Atxaga. In Italia, Obabakoak esce per la prima volta nel 1991 (Einaudi) con l’aggiunta del sottotitolo “Storie”; poi riedito quest’anno da 21 Lettere con il titolo originale Obabakoak. La traduzione in italiano (bellissima) è di Sonia Piloto di Castri.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente